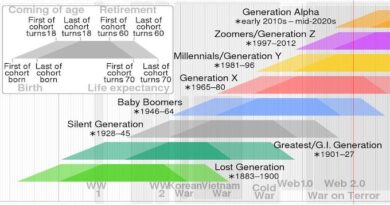L’Arbasino che ci manca
Arbasino è stato sia Bouvard che Pécuchet, ma anche, e soprattutto, un cattivissimo, velenoso Flaubert. Collezionista delle deviazioni dell’animo contemporaneo, oggi appunto continue e patologiche, le ha catalogate con una cattiveria ben peggiore di quella di Flaiano, che non poteva, diversamente da Arbasino, non nascondere la terribile tristezza che lo attanagliava. Moglie pazzoide e matematica, figlia demente, per Flaiano. E andava con le attrici, per annichilire il dolore.
La nostra Casalinga di Voghera, inventore del personaggio come accadeva anche con la sua amica Franca Valeri, lui che era appassionato ed esperto di teatro come pochi, creava spesso un catalogo per madamine efferatissime: l’iconografia della vita bassa, quella sotto il pantalone, di cui Arbasino conosceva, da esperto di cose americane, l’origine carceraria, poi la fisiognomica del parlamentare, proprio lui che lo diventerà con il Partito Repubblicano Italiano e grazie a Spadolini, infine la tipologia dei consumi di massa. Ma senza lagne tradizionaliste né banale accettazione “progressista” dell’esistente. Era troppo snob, ma, talvolta, questo è un vantaggio.
Invece di teorizzare la fine delle lucciole, Arbasino ha fatto la festa anche alla para-cultura del consumo e, di contro, anche a tutte le pippe nostalgiche (lui avrebbe scritto proprio così, pippe) della cultura che si credeva “alta” per mancanza di prove.
La litografia che gli regalò Pasolini era lì a dimostrarlo, in corridoio, mostrando con gli zigomi della “faccia cattiva di Alberto”. Però sapeva, Arbasino, che la cultura di massa avrebbe comunque vinto, e quindi non c’era tempo per le lucciole, gli spinaci freschi, l’odio per i serial TV, la ricotta piena di batteri. Era perfino simpatico, qualora riconoscesse nell’interlocutore la stessa sua cattiveria.
Tra il Beltramme a Via della Croce, poi il baretto con i tramezzini e il suo inevitabile Campari al Gianicolo, tra le erme più massoniche possibili, e ora lì vicino c’è anche la Sede del Grande Oriente, la sua passeggiata romana serale è stata ricca di incontri impossibili: il cameriere che lo informa che “semostati tutti antichi romani”, la ragazza di un noto artigiano di cravatte (è anche e ancora il mio) che dice a Arbasino “nun je ‘aa posso dà, pecché è de li Servizzi”, il romano ma finto milanesizzato, e con Arbasino si sarebbe trovato malissimo, lui che era di Voghera e conosceva Milano come è capitato a un solo altro grande scrittore contemporaneo: Carlo Emilio Gadda, con il quale scrisse un testo piccolo e straordinario, “l’ingegnere in blu”.
Ma chi era poi Arbasino? Un grande dilettante della letteratura, ma, proprio per questo, un osservatore unico delle patologie sociali e culturali. Un anatomopatologo, se magari avesse continuato i suoi studi di medicina a Pavia. E non si capisce niente di Arbasino se non lo si ricollega al suo fondo lombardo, di rane col risotto e formaggi puzzolenti, tra le nebbie annuali.
“Un paese senza” è un ritratto ferocissimo, e ci voleva, della distruzione culturale dell’Italia degli anni ’70, tra terrorismi e politichetta day by day, un testo che fu una sorpresa, mentre tutti i letterati di regime (questo, ma anche quello che si pensava prossimo venturo) corteggiavano il “terrore” e manco lo capivano. E non era nemmeno difficile, poveretti.
Dilettante? Certo, si era laureato con lode in Giurisprudenza a Pavia, che non è una sede secondaria. Mi disse che le zie (inevitabili, in un contesto così gaddiano) l’avevano quasi costretto a una possibile carriera diplomatica. E infatti andò a Harvard, con i soldi ultimi, immagino, della famiglia in ambasce. E i ritratti di Kissinger, di Joseph Nye, ancora giovanissima stella dell’accademia Usa, di tanti altri di cui parlò, prima che altri lo sapessero, su “Repubblica”, che lo pagava poco, furono una rivelazione per molti dei lettori più attenti.
Chissà perché, molti dei grandi della letteratura italiana non sono, salvo rari casi, letterari di formazione: Arbasino esperto di International Relations, e“Repubblica” avrebbe fatto bene a ingaggiarlo per questo, era davvero bravissimo; Carlo Emilio Gadda, ingegnere elettromeccanico laureato al nòster politeknik; Italo Svevo ragioniere e imprenditore; Eugenio Montale, altro ragioniere; Dino Buzzati, giornalista, e bravissimo per giunta; D’Annunzio, laurea fortunatamente non pervenuta; Elio Vittorini, contabile a Gorizia e uomo di Scicli, che voi vedete nei telefilm su Montalbano, fascistissimo in gioventù, ma comunque sempre “di sinistra”; Leonardo Sinisgalli, matematico e manager; Ottiero Ottieri, poeta e ancora manager della Olivetti, addetto alla selezione del personale, che Dio li aiuti; per non parlare del grande chimico Primo Levi; Mario Tobino psichiatra (nosce te ipsum!), perfino un vero scrittore, ma laureato in legge, Carlo Cassola. Che, per essere grandi scrittori, occorra evitare gli inutili studi letterari? È possibile.
E Arbasino era un analista del costume come pochi: ha descritto, caso unico, che io sappia, la felicità profonda dell’Italia pre-sessantottica con un romanzo straordinario, Fratelli d’Italia, un lunghissimo novel on the road che ha riscritto almeno due volte. Ed era proprio quella, l’aura degli anni della Ricostruzione, con la MG rossa sempre aperta, anche tra Lido di Camaiore e il Forte, e le ragazze e (erano i suoi gusti) i ragazzi.
Finì perfino (omosessuale ironico anche su se stesso) a odiare i gay pride. “La letteratura sui gayè settoriale come quella sulle barche, sui funghi e sul Molise”. La chiamò l’Homintern, la lobby gay. E mi ricordo che fece una sfuriata contro questi “circhi di animali”.
Ve lo ricordate l’incipit di Fratelli d’Italia? Eccolo: “Siamo qui a Fiumicino aspettando due amici di Antonio che arrivano adesso da Parigi, un francese e un americano, e non abbiamo avuto ancora un momento per parlare della nostra Estate”.
Ecco, spero che Arbasino sia arrivato alla sua eterna Estate.