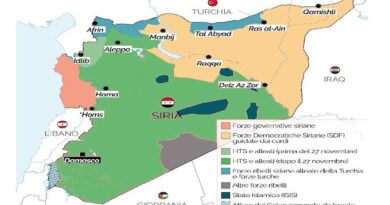Virus e paura del futuro
Il virus ha risvegliato i mostri del Novecento, facendo venire fuori dalle viscere del secolo scorso le ansie, le paure e le inquietudini che negli anni Venti fecero scambiare la libertà con la sicurezza, i diritti politici e civili della nascente società liberale con l’aspirazione al benessere economico illusoriamente promesso dalle dittature degli uomini forti della provvidenza.
Certo, di mezzo (e meno male) c’è l’Europa, c’è il mondo globalizzato e interconnesso e ci sono gli anticorpi della memoria storica delle generazioni più anziane, ma a scorrere le evidenze del Rapporto Censis 2020 non c’è da stare allegri. Non è che manchino le ragioni di preoccupazione nell’anno del Coronavirus, ma è un dato che fa riflettere che il 73,4% degli italiani indichi nella paura dell’ignoto e nell’ansia conseguente il sentimento prevalente. Così come è degno di attenzione che il 57,8% dei connazionali sia disposto a rinunciare alle libertà personali in nome della tutela della salute collettiva: da qui anche l’approvazione largamente maggioritaria (all’80%) delle ultime restrizioni per Natale.
Ma fin qui in gioco è la salute e si può spiegare. Rinviano, invece, al germe dell’individualismo esasperato di questa stagione, un altro portato della pandemia, tanto il dato del 77,1% di coloro che chiedono pene severe per chi non indossa le mascherine quanto il più inquietante dato del 49,3% dei giovani che ritengono che sia giusto che gli anziani vengano assistiti solo dopo di loro.
Ma sono ancora altre le percentuali che sembrano rimandare indietro la macchina della storia nazionale. Il riferimento è a quel 38,5% che è pronto a rinunciare ai propri diritti civili per un maggiore benessere economico, accettando limiti al diritto di sciopero, alla libertà di opinione e a quella di iscriversi a sindacati e associazioni.
Per non parlare del favore (il 43,7%, che diventa il 44,7% tra i giovani) per una soluzione indicibile fino a qualche tempo fa: la pena di morte. Insomma, gli anatomopatologi del Censis certificano che quel «ne usciremo migliori» della primavera del lockdown si sta rivelando, nell’autunno della seconda ondata, una pia e vana illusione. Il mix di terrore per il virus, crollo del reddito, perdita di futuro e caduta delle speranze di una via di fuga a breve termine sta producendo non solo disinganno, rabbia, egoismo multiforme e tentacolare, ma, forse, anche qualcosa di peggio.
Dai sottofondi di una società allo stremo più di quanto non si veda emergono pulsioni anti-democratiche e anti-parlamentari né più né meno come emersero, per altre cause, nella Repubblica di Weimar o nella debole Italietta dei primi anni Venti del Novecento. E quella dicotomia ultimativa «meglio sudditi che morti», di cui parlano i ricercatori della Fondazione creata da Giuseppe De Rita, non è troppo lontana dalle aspirazioni arrabbiate delle masse impoverite uscite stremate e ciniche dalla Prima Guerra mondiale. Ora come allora, lo Stato diventa il salvagente a cui aggrapparsi nel massimo pericolo.
Ma lo Stato, ora come allora, è fragile e disarticolato, mentre il sistema-Italia si muove come «una ruota quadrata che non gira». Senza che si intraveda «un Churchill a fare da guida nell’ora più buia, capace di essere il collante delle comunità».
Sicché non è azzardato sostenere che l’epidemia ha squarciato il velo: il re è nudo. Ma, fortunatamente, tutto intorno non c’è l’Europa delle macerie di Versailles del 1919, ma quella del Recovery Fund del 2020.
[tratto da La Nazione – di Raffaele Marmo]