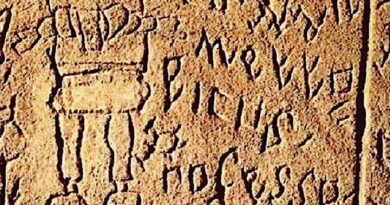Ugo Moretti, Vento caldo, rfb, Ladispoli 2021
A pensarci ora fa un certo effetto considerare che Ugo Moretti ha scritto il suo primo libro, sulla sua tranche de vie personale, da under 30 per così dire nella Roma tra ante e post-guerra, senza spendere una sola volta di troppo la parola ‘tedesco’, ‘nazista’, ‘avversario’ o chi per lui. Forse per questo motivo la Ginzburg rifutò il libro presso Einaudi?
Resta un dato di fatto: il romanzo d’esordio di Ugo Moretti il premio (Viareggio, per carità, mica lo Strega dei circoli alcolemici) se lo vinse nel ’49 quando il suo autore non scontava la crisi tonda dei trent’anni – e quanti se ne vedono invece ancor oggi, sia pure ribassando i trent’anni ai vent’anni di allora, a quel che potevano dire vent’anni – esser già uomo, e padre insomma – nel periodo affrescato da Moretti nel suo libro.
Libro che fin dal titolo porta a spasso il lettore nei labirinti di Giulietta, quella che non crede ai nomi e quindi li cambia sempre, rovesciando come un calzettino il detto audace dei romani per cui tale nome, tanto il presagio. Per dire: il titolo del libro di Moretti, “Vento caldo”, include un nome che di suo è già finto, sconta la nascita da madre prostituta – a Napoli sarebbe stato un Esposito De Domenico o Di Domenico, a Roma invece il protagonista sulla ruota della figliolanza puttanesca prende a nome “Vento” e siccome Roma è pur sempre quella teneramente malinconica di Stendhal, l’autore vi aggiunge “caldo” per descrivere un’atmosfera che non conosce mezze stagioni ed è purtroppo ben nota a chi legga Moretti nel 2021, grazie alla ristampa di rfb editore – reader for blind.
Direi che è un libro prestigioso, di restauro del romanzo picaresco, alla come viene viene, una lunga lettera incorniciata su Claudia e che poi ha preso il passo delle trecento pagine, senza una sbavatura che sia voluta, sono tutte lì, a prova di editor imbecille dei nostri tempi, ingordi e avari di grammatica, punteggiatura e quante altre ideologie ci si possa inventare “una volta che la storia è finita” giusta lo sventurato motto di un libro che è bene sia dimenticato rapidamente, e presto dissolto.
Claudia, l’eterno femminino, la solita rincorsa imbecille verso la goliardia dell’amore romantico, nonostante lei sia di ceto elevato, nonostante sposi un energumeno – biondo e bello e per di più fascista, amico di Starace, quindi figliolanza garantita in nome del posto fisso anche coi repubblichini e crepi l’avarizia scocciante degli amori passati, cara Claudia, ti scorderai di Vento sinché non lo ritroverai dopo la seconda parte del libro – che ha tenori altissimi, stacca di diverse lunghezze i racconti di Calvino under 30 sulla guerra, sia in prima che in terza persona perché in Moretti tutto è lampo personalistico, come un Bettiza redivivo ma senza l’acne psicologica pungente dell’istriano: la guerra ritratta da Moretti è storia incisa nella pagina, ad altezze di episodi degni di Fenoglio, con quel carattere davvero indimenticabile del Coniglio, il ragazzo di 19 anni che Vento protegge come potesse essere suo figlio quando invece si passano solo dieci anni ma si sa, sui campi la mira deve essere sempre buona.
E quindi la carrellata finisce con la calata dall’Albania all’Emilia, alle braghe disciolte dopo quattro mesi in un casino di Reggio, poi siamo di nuovo a Roma in un finale salmodiante dove da una pagina all’altra ti aspetti che irrompa uno stilema qualsiasi della Morante e invece no: Moretti persevera nella sua lettera d’amore a Claudia, infine ricostituita in figura che sfancula il biondino una volta che Vento lo ha gettato nel Tevere. E tant’è, con buona pace della Ginzburg che dopo sfogliato il romanzo lo nascose a Pavese e quindi Einaudi non lo pubblicò.
A meno di un anno dopo da questa lettura precipitosa Pavese sfogliò il libro nell’edizione Faro scusandosi, per come lo si può fare nella società letteraria, col più giovane Moretti: e gli dedicò una copia del Mestiere di vivere apponendo in esergo, accanto a “vivere”, la parola “da scrittore”. Tanto basti per smontare una volta per tutte il mito del diario di Pavese come lettura fenomenologica di un’epoca, come tratto vivente della letteratura – perché insomma il diario di Pavese, per quanto possa sembrare crudo e prematuro, non è vita né esistenza, è proprio una gran menzogna, è l’atto del vivere da scrittore inteso come finzione, e siamo lontani gli anni luce dalle visioni cosmiche, panoramiche di un Camus, di un Sartre.
Il diario di Pavese è un testo erratico così come lo è “Vento caldo” di Moretti e stan lì entrambi a comprovare quanto avesse ragione Auden nello scrivere in versi che tra nord e sud si apre un golfo che nessuno sa stringere, manco con l’abbraccio amoroso: al nord c’è la formazione, l’uomo che esce dal gorgo peccaminoso per autoeducarsi e siamo alla propulsione fichtiana, romantica dello stato interiore, dell’etica stabilizzata a norma d’azione estetica, con tanto di appigli un po’ ovunque – Goethe e altri che si dilettarono nell’autobiografia.
Dall’altra parte del golfo c’è Moretti, la nostra Italia, il nostro meridione letterario e vitale di un’Europa che languidamente rifiuta i tentativi romanzeschi che sian esito di un’autoeducazione incompiuta, romanzi picaresci insomma.
Questo è quanto. In Italia non abbiamo il romanzo di formazione, quando va bene fa una comparsata quello di deformazione e le passioni, le strategie sentimentali restano lettera morta, un apercu vitalistico di un under 30. Scordato dai contemporanei, anche se poi fece lo sceneggiatore, e ampiamente, quanto boriosamente, ripreso in mano dai posteri per sentenziare le amenità che avete letto sin qui.