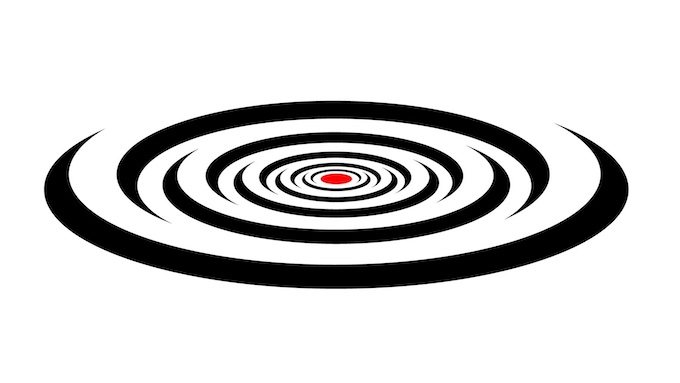Michele Porcelli, Il suono di una goccia, MDS, Pisa 2025
E’ difficile stabilire l’appartenenza del lavoro di Michele Porcelli a un genere preciso. Il direttore della collana dove il libro è pubblicato lo definisce “romanzo d’eternità”. Con una sfumatura concettuale diversa, potremmo parlare di un’opera legata allo “illusionismo onirico”, pensando non soltanto a René Magritte, il disturbatore silenzioso, ma anche al valore di certe parole, e a situazioni espressive, che sembrano eternate da oceani di silenzio.
In ogni caso, i personaggi di questa “perdizione” sembrano vivere dentro una prigione, un labirinto costituito da tutto quello che si nasconde dentro ognuno di noi e che è costruito col materiale dell’eterno ritorno di terrori, riti, iniziazioni che fanno parte della archeologia esistenziale del genere umano. Non è , infatti importante, stabilire epoca e luoghi in cui si muovono, elettrizzano la loro fisicità, geometrizzano i loro sentimenti Liza, Lumina, Lucas, Matthias e gli altri personaggi, dove e perché avvengano le loro morti, le dissolvenze, i rapimenti erotici, come funzioni l’esasperante robotica, la macchina grottesca creata alla maniera di Kafka. Ciò che conta è, come scrive Giorgio Caproni, che”il poeta è un minatore: è colui che riesce a calarsi a fondo in quelle che il grande Machado definiva “le segrete gallerie dell’anima (“las secretas galerias de l’alma”)”. La poesia, la letteratura può rivelarci, come sapientemente riesce a fare Michele Porcelli, tutte le emozioni, le inquietudini, gli incubi che sono dentro il nostro inconscio, tutti gli strati del vissuto che ogni essere porta dentro di sé, dall’inizio della storia, dell’avventura, del viaggio collettivo, dalla visione confusa di se stessi e del mondo alla percezione dolorosa del male di vivere come forma alta di consapevolezza.
La letteratura può dunque essere anche immaginata come una liberazione vissuta attraverso una “sintassi libera dai condizionamenti, dalle sofisticazioni censorie della razionalità”. Proprio perché,come sosteneva Camus, l’assurdo è la vita stessa, è il mondo dinnanzi all’uomo e determina l’impossibilità, da parte della ragione, di comprenderlo in modo definitivo.
Nel romanzo di Porcelli, assistiamo a una situazione di dinamica narrativa che può essere raccontata con le parole che la studiosa di Beckett Rosangela Barone usa quando, nella sua opera Il divertimento Beckettiano, spiega che il grande irlandese ha dato al suo personaggio il nome Godot perché unisce due parole “go” e “dot” rispettivamente “va” e “fermo” poiché “dot” in inglese è “punto”, per alludere così alla frustrazione dell’uomo nel suo tentativo fallimentare di “muoversi”, procedere, cambiare, di uscire da quello che Ernesto Che Guevara chiama in una sua lirica “FREDDO STEPPARIO dell’assenza. Tanta complessità, ed è questo il tratto davvero strabiliante di quest’opera narrativa, è resa dall’autore con l’avvincente autorità di una lingua luminosa e capace di farci muovere a più livelli dentro il testo: le vicende, lo spessore dei personaggi che hanno il segno grafico per portare il lettore in climi letterari che possono procedere dalla vastità tolstoiana dei grandi spazi al carattere composito di paesi e città dal mosaico articolato e animato dalle diverse etnie proprie della Mitteleuropa ottocentesca; la cura, da parte del raffinato narratore, nello scegliere fonti letterarie che hanno fatto da ponte tra la classicità e quelle che saranno la componenti delle avanguardie artistiche che rivoluzioneranno tutti i sistemi della comunicazione culturale.