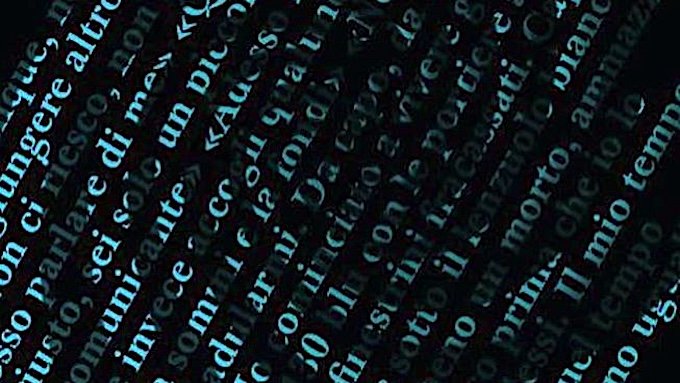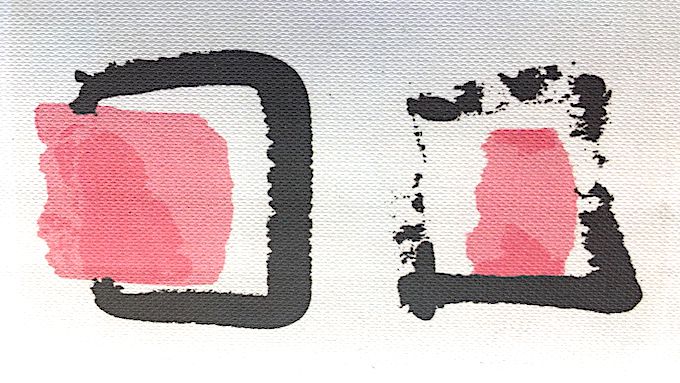Alberto Casadei, Anni ombra, Polidoro 2025
“Dunque, non sai aggiungere altro?” Questa è la frase con cui si apre Anni ombra. Come a dire: tutto è già stato detto. E se tutto è già stato detto, come fa un soggetto, un io a parlare di sé in seconda persona? Cioè al se stesso che di volta in volta prende le forme e la sostanza di qualcun altro, di qualcos’altro? Quindi già l’incipit, anche con la trovata del “vasetto incomunicante”, dispone il lettore in una porzione di mondo riflessivo.
Qualche giorno fa, su La Lettura, Chiara Fenoglio ha tracciato il punto su questo ultimo libro di Alberto Casadei. Scrive, sull’inserto letterario del Corriere della Sera: “Liberandosi completamente dalla dittatura dell’inventio, Casadei approda a una narrazione in cui le forme del dialogo, del saggio, dell’interrogazione e del verso lasciano da parte il filo della continuità e privilegiano un andamento pulsionale, poiché è nell’istante che si può forse restituire la dimensione del «reale senza l’immaginario»”.
Si capisce da questo passaggio che siamo di fronte a un libro difficilmente qualificabile. Potrebbe essere un saggio, un romanzo, un poema, un prosimetro o altro. Questa prova del dantista esperto è densissima e difficile da contenere in un genere o in una descrizione del tipo “questa è la storia, parla di questo”.
Dentro ci sono passaggi lirici e momenti stranianti, ma anche tanta autoriflessione e metadiscorso. Siamo di fronte a un pezzo di letteratura che mentre racconta si interroga su ciò che sta raccontando. Ma non è un espediente, piuttosto la complessità dello studioso che da autore si polverizza in ragazzo, adulto, figlio e discepolo, docente e poeta, critico e umorista, una parcellizzazione di identità che si ricompongono nell’opera non in un intreccio possibile, ma in suggestioni improvvise, pulsioni e sentimenti che salgono in superficie attraverso le parole. In un passaggio del libro l’autore scrive: “Ripenso a ogni pagina, a tutti i libri. Ogni lettura è ormai un’introduzione. Si cita, si rinvia, il mio corpo è in attesa di fronte a ciascuna riga che è già stata scritta.” Ecco, Anni ombra è forse un tentativo di comprendere nella scrittura lo scibile universale dell’osservatore non oggettivo ed eteronimale anomico, cioè dei punti di visione artificiali di sé che non attivano una vicenda, ma resistono nella complessa costruzione anti-autoriale.
Per esempio, la sezione “Di qui in avanti” chiarisce piuttosto bene le pagine precedenti e ciò cui mi riferisco. Come se, a un certo punto, un ramo trasversale e insolente della coscienza anti-autoriale cominciasse a infierire sul portato del discorso composto fino ad allora, come in questo passaggio: “… la gente vuole la ciccia del racconto, no ‘ste elucubrazioni da io puro”.
È una sezione deliziosa e sfacciata, e anche molto divertente. Ci sono passaggi eccezionali tra le parti che descrivono in soggettiva questioni oggettuali, le parti teoriche, le parti testimonial-autobiografiche. Insomma ci sono paragrafi veramente godibili. Tipo: la parte in francese su questioni psichiche, il Berlusconi definito mezza sega, lo zibaldoncino, il tu-lui che non si spiega spiegandosi fin troppo, lo yin e lo yang che “spaccano”, i continui riferimenti alla tecnologia e alla pittura, con la vita dentro le gocciole di tinta di Pollock, le citazioni dantesche, ecc.
Il passaggio finale sul momento futuro in cui siamo già altrove non è scontato, ma sappiamo già da tutto quello sostenuto in precedenza che siamo di fronte a una scrittura di domani. Siamo davvero già su Marte.
Questo libro ha sprazzi di geniale carattere, come le pagine da 120 a 129. Il pezzo che comincia con la frase “Mettiamola così” è strepitoso. Introdotto da due paragrafi corti, quello sul thaumazein e il “Come back to reality”, ma pure il seguito, cioè i due paragrafi successivi, è fortissimo: il primo (quello del pippone) esilarante, il secondo del ricordo d’infanzia vertiginoso.
Può non essere facile per il lettore meno forte contenere tutto ciò che questo libro pone in risalto, ma arrivare a punti come questo appena descritto è gratificante.
Infine le poesie sostanziano e certificano il percorso del libro fino alla fine. E tuttavia è ancora una frase a colpirmi per la sua decifratura del mondo attuale del romanzo – e verrebbe da dire del libro in generale: “Un intelligente sacerdote diceva: in confessione arrivano mogli e mariti che parlano dei loro adulteri, ragazzi e ragazze con tutti i loro atti impuri, vecchiette che parlano male di altre vecchiette… E io: dovete proprio venire a raccontarle a me queste faccende?”.
Ecco, Casadei forse ci dice pure che il romanzo attuale si è un po’ ridotto a questo: le storie tanto per, edificanti o immorali o ‘dal vero’, ecc. Insomma, cari scrittori, fate tesoro di nuove forme di narrazione come questa di Casadei. Mica vorrete continuare a venirci a raccontare le solite faccende…