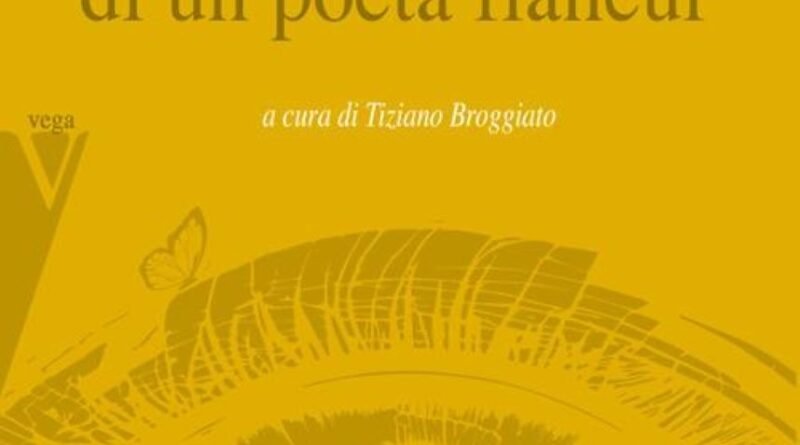Maurizio Cucchi. Stile e umanità di un poeta flâneur, a cura di Tiziano Broggiato, Luigi Pellegrini Editore 2025, pag. 96.
A settembre 2025 Maurizio Cucchi ha compiuto ottanta anni, e come dono Tiziano Broggiato si è rivolto ad alcuni dei suoi amici ed estimatori e ha raccolto le loro testimonianze sul poeta, nella consapevolezza che Cucchi è “uno dei nostri pochissimi poeti, susseguenti all’insegnamento di maestri come Sereni, Giudici, Raboni, destinati a seguirne la traccia nella storia della letteratura italiana”.
In Stile e umanità di un poeta flâneur compaiono così le voci di Alberto Bertoni, Gian Mario Villalta, Vivian Lamarque, Roberto Galaverni, Roberto Mussapi, Valerio Magrelli, Mario Santagostini, Giancarlo Pontiggia, Patrizia Valduga, oltre a quella del curatore. Niente di meglio per fare gli auguri in amicizia e affetto, ma anche con una dimostrazione di profonda conoscenza della poesia di Cucchi, l’autore milanese “capace di imporre un gusto, uno stile, una poetica”.
Broggiato scrive che i versi di Cucchi “percorrono una linea che insegna a commisurarsi col presente. Ne scaturisce un carattere di necessaria vitalità, di movimento, ma anche di senso della fragilità, della nostra vulnerabilità”. E oltre alla presenza, nei suoi versi, del luogo amato, Milano, con il suo orizzonte familiare, Broggiato riconosce che Cucchi “ci propone una poesia ipotattica che si addentra in vie non frequentate, in scenari che inducono a nuove interrogazioni” e che “fissa dunque il centro della sua ricerca in traiettorie di vita lontane, loghi perduti e ritrovati, affetti custoditi”. E ci riporta al poeta flâneur del sottotitolo.
Di varia natura e contenuto i contributi dei poeti sopra citati: Bertoni riconosce in Cucchi il migliore erede di quella “scuola milanese “che si sviluppa a Milano nel secondo dopoguerra; ricorda tutti i poeti che di Milano hanno fatto e continuano a fare il loro punto di incontro, si sofferma sul capolavoro del Disperso (1976) e Sindrome del distacco e tregua (2019), in cui riconosce “un predicato di frugalità. Abito mentale dell’io, ma soprattutto medium per umanizzare la realtà” che si avvale “di modalità davvero sperimentali di scrittura e d’espressione”, in quanto “alla polifonia e drammaturgia metrico-prosodica di cui Cucchi è maestro, si aggiungono qui stacchi di prosa tutti funzionali”.
Villalta si sofferma su “quanto può contare il non detto, la ripetizione, la simmetria (proposta o incompleta), la tessitura segreta, in somma del testo, la voce che emerge e si inabissa sulla pagina e, di conseguenza, nella mente di chi legge”. Si sofferma in particolare sul dissidio, la dissonanza esistente tra l’idea di un’opera che nasce già in antico per raccogliere il tempo in una sfera chiusa e coerente, e le trasformazioni della vita che continua a svolgersi, per cui “il rapporto tra la realtà e la mappa (la tradizione, la lingua) è insidiato per sempre”. La voce di Cucchi, secondo Villalta, non grida mai, non vuole scuotere, e la singola poesia non rende conto del lavoro del tempo nella dimensione del libro.
Quello di Vivian Lamarque è un augurio che recupera momenti trascorsi insieme, quando la abitazione di Cucchi diventava il punto di raccolta di tanti poeti del ‘900. Peccato che molti se ne siano andati: “Intanto, in questi album di fotografia che ho riaperto, – lei scrive – stanno sfilando come fossero viventi troppi poeti che ormai da anni ci hanno lasciato”. Eppure sulla nostalgia vince il sorriso, con il ricordo dei gatti in mezzo a loro, come Ciccia, che osservava dall’alto di un pensile di cucina cosa avevano nei piatti e anche ogni mossa dei presenti: guarda come a chiedere /ma cos’è? /cos’è e poi si acquatta” (da Poesia della fonte) E ricorda i gatti di Raboni, di Zanzotto e gli altri due di Cucchi, Gigia e Zoe.
Roberto Galaverni riconosce che Cucchi sa “trovare d’acchito, con grande economia di mezzi espressivi e come se niente fosse, la frequenza e la nota giuste”, con una poesia “che cancella le proprie tracce, ma non il proprio tono, la propria intensità”. Poesia che cela una commozione “che di rado si vede, ma si sente”, dove “la bravura di Cucchi sta innanzitutto nella sua capacità di intercettare una particolare frequenza di discorso che all’improvviso, senza nessuno scarto, privilegio o solennità, sembra passare direttamente sulla pagina dai pensieri, rovelli, rimuginii e obnubilamenti del poeta, in un territorio spesso indicibile tra la veglia e il trasognamento”, producendo un effetto di straniamento anche nello svolgersi del quotidiano.
Roberto Mussapi apre con questi versi: Dopo la notte rannicchiata / il vicolo del ghetto amico / nello squallore gelato e io giravo / l’angolo, veloce, nell’oscuro / rigore inopportuno dell’ora (Sindrome del distacco e tregua) e si sofferma sull’antitesi positiva e drammatica sonno veglia ricorrente nella poesia di Cucchi, onirica e realistica allo stesso tempo, poesia del “dramma e delle meraviglie che solo nel quotidiano si manifestano immediatamente all’uomo” dove “un impulso etico, nobile, coraggioso, muove il viaggio”, senza enfasi alcuna, ma nella “strenua difesa della poesia, come forma di conoscenza, e anche di esemplare e necessaria esperienza”.
Gli auguri di Valerio Magrelli sono una poesia a lui dedicata, insieme al ricordo di quasi “cinquant’anni di lealtà, generosità, intelligenza e simpatia” che lo legano a Cucchi, a partire dal loro primo contatto telefonico, nonché delle occasioni di incontro a Milano, sulla scia dei traslochi della propria figlia che gli ha fatto da guida nella sua avventura milanese.
Mario Santagostini dedica a Cucchi una Poesia senza titolo, in cui, con vicinanza affettiva non priva di umiltà, scrive che “raccontare una vita sarebbe, adesso, un gesto strano, e zeppo di tagliole. Dove, a volte, credi di parlare di te stesso, poi avverti che parli ancora, ma di qualcun altro. E non sai di chi. Ma senti la tua, di vita è forse solo l’immagine, il ricalco di altre vite”.
Partendo dall’esergo a Il disperso (1975) tratto da Gaston Bachelard: Anche la mucca ha il suo principio di interiorità. / esige una casa, l’ambiente modesto / e segreto dove l’inconscio vive, Giancarlo Pontiggia cerca le chiavi di lettura della poesia di Cucchi, sottolinea la centralità della casa, e anche del corpo, come luogo di intimità, concorda con la intuizione di Alba Donati secondo al quale Cucchi “non cancella il dato drammatico, spesso tragico dell’esistere, ma lo esorcizza entro un perimetro di calda vita, di oggetti che perdono man mano la loro concretezza, si smaterializzano, fino a disperdersi nel crogiolo della mente e del sogno”.
Patrizia Valduga offre a Maurizio quello che lei dice di saper fare di meglio, cioè una traduzione. “Il poeta che sto traducendo – dice – è Michael Palma, poeta traduttore, oltre che di Dante, anche di Raboni e di Cucchi. Mi pare quasi che si chiuda un cerchio caro e splendido”.
Nella prima parte di questo omaggio augurale troviamo una serie di nuove poesie di Maurizio Cucchi raccolte sotto il titolo Nella piatta illusione del tempo, nonché un racconto inedito, Isabella da Lampugnano, che si ispira a una storia accaduta nel 1500, una storia di stregoneria e di orrore, che ha tutte le caratteristiche di una favola.
Nella piatta illusione del tempo, / nella comunità precaria / dei morti e dei vivi, / Non si cancella l’offesa, non si modifica / Il senso della storia. Nel presente / Totale la vittima / E l’assassino conservano / Espressioni diverse, facce / Opposte: il nero / resta nero e la storia / Non lo stinge, non lo sbiadisce / mai.
Sono versi carichi di pietà umana, di consapevolezza dolorosa del ripetersi della storia, del male che sta acquattato nell’uomo, quel nero che non si stinge nemmeno col tempo, pronto a manifestarsi in ogni momento.