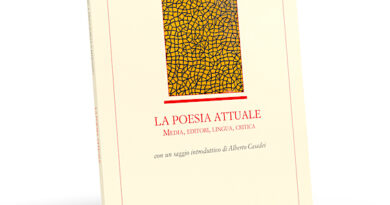Tito Barbini, L’ultimo pirata della Patagonia, Mauro Pagliai Editore 2015
Ho grande stima di Tito Barbini. Ne ho stima come viaggiatore e ne ho stima come uomo. Le sue scelte di vita (uscire in silenzio dalla politica e poi mettersi in viaggio nel mondo per scoprire se stesso e le storie degli altri) sono un esempio per chiunque ami vivere le sue avventure con passione e schiena dritta. Quindi potrete pensare che quello che scriverò del suo ultimo libro siano le considerazioni di una persona che ha letto con occhi di ammirazione le pagine de “L’ultimo pirata della Patagonia”. È possibile. Ma ogni critica è motivata da dati extratestuali, quindi tutto sta nelle regole stabilite per il povero recensore. Il libro comincia con una specie di prologo dove l’autore si schernisce e dichiara i dati essenziali del suo viaggio e delle sue condizioni di viaggiatore e scrittore appassionato: “Un narratore avanti con gli anni, appesantito nei movimenti, in viaggio con mezzi di fortuna, in cammino dalla Patagonia alla Terra del Fuoco. Insensato, appunto. Qualcosa che fa a cazzotti con l’età e con la salute”. Dunque una descrizione dallo statuto contingente del narratore in viaggio, che racconta mentre agisce. Tuttavia è col primo capitolo che l’autore esce momentaneamente dall’autofiction e attiva un tipico incipit da romanzo: “Il giorno che l’anarchico russo Simon Radowitzky si apprestava a evadere dal bagno penale di Ushuaia, Pasqualino Rispoli si alzò presto per mettere in mare la sua barca. La prima aria del mattino richiamava gli odori del porto al risveglio. L’aroma del caffè arrivava dalle case dei pescatori mescolandosi a quello acuto delle alghe marcite”. Il libro racconta la storia di questo marinaio di Torre del Greco, di questo Corto Maltese ante-litteram, Pasqualino, che aveva imparato a navigare nel Mar Tirreno, e conduceva con maestria barche presso la Terra del Fuoco da analfabeta, senza consultare mappe né conoscere metodi di navigazione. È così che l’autore torna in Patagonia, dove aveva raccontato le gesta di Alberto Maria De Agostini, cioè Don Patagonia, con un nuovo personaggio italiano che intreccia la sua attività di pirata buono con l’anarchico russo Radowitzky. Il libro descrive soprattutto due luoghi di quel mondo alla fine del mondo, cioè Punta Arenas (“una città inutile e indispensabile”, o anche “una città di servizio, un punto strategico nello Stretto di Magellano”) e Capo Horn (“[dove] si costeggiano i limiti segreti del mare. Capo Horn inghiotte navi e uomini, dicono i marinai”). Ma in questo libro si parla anche di altri personaggi e autori che hanno frequentato le zone del racconto, da Charles Darwin ad Antoine de Saint-Exupery che in una lettera alla madre scriveva: “Ho fatto un lungo volo di 2.500 chilometri in un solo giorno, è stato bellissimo tornare dall’estremo sud, dove il sole tramonta alle dieci di sera, presso lo Stretto di Magellano. Là tutto è verde: città sui prati. Strane piccole città di lamiere ondulate. E gente che, a forza di sentire freddo e di raccogliersi attorno ai fuochi, è divenuta simpaticissima”. Ecco un espediente dell’autore, quello di raccontare non solo i luoghi e le storie, ma recuperarne anche le testimonianze, la letteratura. E l’ultimo scoglio che Tito Barbini cerca di evitare è quello di incensare chi nella letteratura di viaggio è stato riconosciuto come il campione della Patagonia, cioè Bruce Chatwin. Con ampia conoscenza dei testi dello scrittore inglese, il nostro autore scandaglia sul campo, nei testi e nelle fonti le mancanze del mito letterario patagonico, arrivando a mettere Chatwin di fronte alle proprie responsabilità. Tutto questo parte da un capitolo precedente a quelli in cui si affronta Chatwin, e cioè dal capitolo intitolato “in viaggio”. È lì che Barbini sviscera il suo compito di osservatore non solo delle geografie fisiche e umane dei luoghi, ma anche della storia, dell’analisi delle storie che in quei luoghi è passata: “La prua avanza per ore, testarda, sfidando le foche, i deflini, i leoni marini e le balene, lasciando di poppa un sentiero di spuma bianca. Anch’io sono in viaggio, come Pasqualino, e viaggiando racconto. Anzi, è come se fossi assieme a Pasqualino. A lui affido le parole che servono alla sua storia”. Ed ecco dove si trova l’autore che narra. L’autore che dedica anche un capitolo quasi metodologico per spiegare cosa significhi essere in un posto e raccontarlo. E lo intitola (con un eco da un libro di Chatwin, che è “Cosa ci faccio io qui?”), “Dove mi trovo?”. E prima aveva pareggiato i conti con lo scrittore inglese scrivendo: “Chatwin arriva a Punta Arenas, nella Patagonia cilena, mentre nelle strade ci sono i carri armati del generale Pinochet. La gente ha ancora negli occhi il bombardamento del palazzo della Moneda e l’assassinio di Allende. Chatwin non racconta nulla della straordinaria situazione che affondò la grande democrazia cilena”. Una resa dei conti dovuta al fatto che il nostro autore aveva amato per lungo tempo Chatwin, dando forse troppo rilievo alle storie romanzate dell’inglese, mentre il suo libro realmente necessario è quello in cui sono antologizzati articoli e riflessioni quasi ombelicali sul senso del viaggio (“Anatomia dell’irrequietezza”), invece dei lunghi racconti di viaggio.