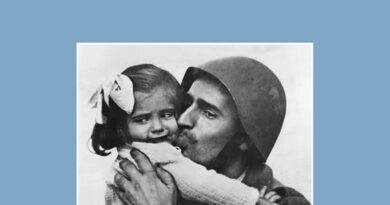Marieke Lucas Rijneveld, Mia diletta, Nutrimenti Editore 2022, pag. 320, trad. Marco Cavallo
Tra i polder olandesi, sconfinati, un veterinario di quarantanove anni va da una stalla all’altra ogni giorno per curare le mucche; gli allevatori non hanno dimenticato la soppressione di intere mandrie per colpa della mucca pazza, davanti agli occhi pende ancora qualche corpo impiccato per disperazione. E’ il 2005.
Lei è una adolescente di quattrodici anni che vive col fratello più grande e il padre allevatore.
La conosciamo piano piano nella lettera che le invia Kurt – così a lei piaceva reinventarsene il nome- nominandola con il vocativo “mia diletta”, o qualsiasi altro appellativo, mai col nome proprio.
E’ una adolescente strana, un po’ bambina, un po’ adulta riflessiva, saggia e profonda. Chiara e oscura. Riflette a fondo sulle cose e ama la musica. Ma soprattutto ama volare.
Qualcosa l’ha ferita, l’ha bloccata psicologicamente: nella sua vita c’è un vuoto enorme lasciato dallo “scomparso” e dalla “abbandonata” quando lei aveva solo quattro anni.
Avviene di frequente che i figli si addossino la responsabilità di situazioni dolorose che riguardano i genitori, come se tutto fosse colpa loro: in questo caso il dramma è stato così lacerante che lei, in una forma di vaneggiamento, di delirio, si ritiene l’esecutrice dell’attacco alle Torri Gemelle del 2001! Perché lei sa volare, è un uccello! E guarda un alto silos nel cortile, e sa che un giorno spiccherà il volo di lassù. Nello stesso tempo ammette: “c’è qualcosa che non va in me”.
E’ una creatura che vive di immaginazione, sogni, proiezioni surreali, anche quando frequenta la scuola o aiuta nel lavoro della stalla aggirandosi tra mucche, vitelli, letame.
Lui – chiamiamolo dunque Kurt – ha una moglie insegnante e due figli adolescenti, è un veterinario conosciuto e apprezzato. La sua lettera/romanzo è una confessione, un flusso di coscienza che non prende mai respiro né lo permette al lettore, come un torrente che scorre impetuoso senza che un isolotto riesca a rallentarlo.
Vengono in mente il flusso di coscienza di Joyce, il romanzo psicologico di Svevo, la Lolita di Nabokov, ma Rijneveld, pur con questi rimandi, ha tracciato una strada tutta nuova, in un percorso che aggiunge elementi a piccole dosi e ad ogni momento stupisce fino all’indignazione.
La leggerezza della ragazzina lo attira, quel suo contrasto di ingenuità e saggezza lo affascina, quella purezza assoluta alimenta in lui i desideri più mostruosi, il pensiero di lei lo perseguita, lo rende schiavo della passione per un’intera estate.
In lotta tra ragione e istinto, lui si insinua nella vita della bambina, la circuisce, la adesca, la corrompe, accetta ed alimenta il suo farneticare, la incuriosisce sempre di più, la ammalia con le canzoni che lei ama, la stordisce con citazioni letterarie e passi biblici, la eccita in ogni modo e con ogni stratagemma. Le fa nascere il desiderio, lui come unico maschio di riferimento per la scoperta della sessualità.
Di tutto questo si confessa, rovesciandosi l’animo, nella lettera romanzo alla sua diletta, al “fuoco dei suoi lombi”, al suo “puttino”. Tardi, perché il male è già stato fatto, fino in fondo.
Mentre il lettore vorrebbe intervenire per dire alla ragazzina che si è fidata – fermati, basta così – cresce la condanna per il carnefice.
C’è una umanità sorda intorno a loro, c’è silenzio, solitudine. C’è un materasso preparato sul retro del furgone da lavoro, c’è odore di stalla: lui insemina vacche, poi corre dalla sua “vitellina. Solo centinaia di occhi bovini li osservano.
E’ molto materico, fisico, questo romanzo, non c’è un cenno di tenerezza se si escludono i gesti finalizzati ad un unico scopo: “ti ho messa in calore con un’iniezione come facevo con le mucche accelerandone l’ovulazione”
C’è mancanza di dialogo vero, di comprensione e soprattutto di pietà: il corpo di lei è ritenuto peccaminoso dal padre, disgustoso, non più degno di entrare in una chiesa; invece lei, che si esercita a volare sbattendo le proprie ali, ha tanta paura anche a correre da sola per i polder, alla sera, sempre più magra, sempre più pallida.
Ma le vittime sono due, anche se niente può scagionare Kurt, perché qualsiasi sia stata l’infanzia, qualsiasi danno si possa aver ricevuto, il tempo della vita dovrebbe permettere una ricostruzione di sé.
Abusato ripetutamente dalla madre da bambino, con le minacce gli era stato negato lo sguardo su altre donne, così aveva imparato a osservare solo le bambine: la madre “aveva fatto germogliare un desiderio insaziabile, una ferita permanente che cercavo di guarire attraverso di te, sperando così di dimenticare i gelidi anni della mia infanzia”.
Negli anni aveva imparato a gestire la sua vita con una parvenza esteriore di normalità, ma la menzogna aveva messo radici profonde.
Lo scomparso e l’abbandonata prendono forma piano piano: lui, un fratello vittima di un incidente stradale mentre attraversava la strada e lasciato sul ciglio; lei che indossava un abito blu quando era partita -solo questo ricorda la bambina- un blu scuro come la sera, come il buio che le si è accampato dentro.
Un romanzo duro, crudele, alla cui mancanza di respiro ci si abitua. Un torrente da cui ci si lascia trascinare, come se il narratore avesse adoperato anche nei confronti del lettore le stesse arti di adescamento rivolte alla sua diletta.