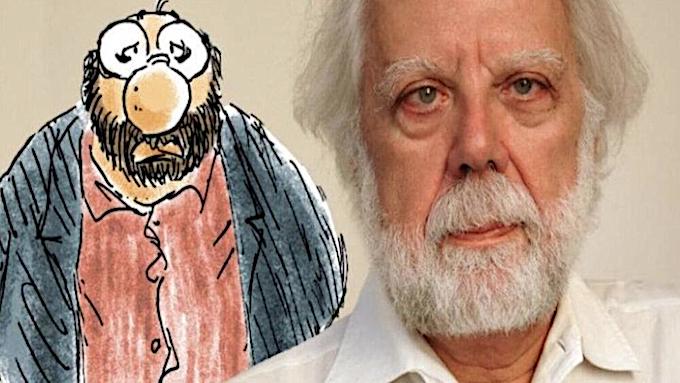Mino Trafeli: il teatro di sculture
Esterno mattino: sono le sei, è il 20 febbraio 1981, freddo, alba livida ma in argenteo stato di grazia, insomma “alba di perla”, per derubare un grande poeta, e la torre di Pisa, realizzata nei cantieri della Hollywood sul Tevere, e poi messa insieme alla maniera del puzzle, sotto la direzione nevrotica e geniale di Mino Trafeli, è finalmente montata. Giorni e giorni di regia. Lo scultore volterrano, il nostro Maestro, del resto, aveva l’autoritarismo del capocomico, del rigoroso costruttore di storie che, oltretutto, sono pensate per dirigere non gli uomini, ma le sculture, realizzando il vecchio sogno di animarle, di dar loro la vita, il soffio biblico che il mito ha attribuito a Michelangelo Buonarroti.
Un carnevale particolare, quello pisano del 1981, titolo La ragione insidiata, o, meglio, un carnevale pensato in maniera storica con la capacità di tornare alle sue radici irriverenti, eversive, con in più il criterio della originalità, intuita come espressione della libertà e non come licenza premio per una obbediente sottomissione al potere. Qualcosa, dunque, che univa la vendetta gaglioffa dell’antica goliardia, con la capacità di giocare alla moltiplicazione concettuale, alla presentazione simultanea di tutte le facce di una realtà diventata, invece, per lusinga e repressione, luogo a molte entrate e a nessuna uscita.
C’era moltissima gente attorno al “doppio” del monumento, dell’opera architettonica così celebre da esserlo più della stessa città che la ospita. Tutti erano curiosi di comprendere la motivazione del gioco teatrale di Trafeli, di capire il perché di questo inserimento metafisico del campanile, capace quindi di diventare inquietante, enigmatico, di costruire, attraverso la moltiplicazione, la dimostrazione di quanto il caso spesso collabori alla genialità di un artista. Del resto, questo è quello che Abert Einstein aveva scritto, nel 1953, al professore Russi docente nell’Università di Pisa: “La torre di Pisa simboleggia in modo esemplare l’impossibilità degli esseri umani di prevedere le implicazioni sociali delle loro opere. L’artista naturalmente non suppose che la debolezza delle fondamenta avrebbe dato alla torre un’inclinazione tale da arrivare all’attenzione di tutta l’umanità. È forse quanto si verifica anche per le creazioni più astratte dell’uomo, nel senso che le loro effettive conseguenze sociali corrispondono solo in minima parte alle intenzioni del creatore”.
Aggiungo che Mino, inventore, regista, manovratore, marionettista, ventriloquo, Maestro di una immaginaria orchestra, sicuramente presente in un golfo mistico, occultato magicamente sotto le Logge di Banchi, lui, cacciatore di linguaggi, maratoneta impegnato lungo le contorte strade del Novecento, moltiplicava le potenzialità simboliche e discorsive della sua creatura, del suo teatro cilindrico, inclinato, per un clownesco sberleffo alla pachidermica lentezza e ottusità del potere: la torre, altra, speculare, come simbolo della resistenza della creatività dell’arte in contrasto con la sua apparente fragilità.
L’azione, la performance, va detto, era dentro un nuovo periodo progettuale, emerso da una fase rivoluzionaria del percorso dell’artista volterrano.
Nel suo volontario, e felice, esilio fuori dai circuiti della centralità avanguardistica, nella appagante solitudine della nostra città austera, solenne, sospesa su un territorio luminoso, ampio acceso dalle luci porporine dei tramonti marini, in mezzo alla materia, alle pietre legate all’identità alabastrina, Mino aveva dato vita a una sperimentazione aperta a mezzi di comunicazione modernissimi e legati a una polivalenza comunicativa variegata da tratti che rimandavano al cinema, alla fotografia, alla televisione, alla musica sperimentale (Cage come esempio per tutti), al teatro ovviamente. Un teatro che univa strutture che appartenevano alla tradizione rinascimentale e shakespeariana, al periodo del ritorno, alla recitazione di strada, alla mimica dei giullari, per arrivare a intonazioni e aspetti che implicano la conoscenza e il recupero di Antonin Artaud e Samuel Beckett con rimandi, non credo involontari, a Osborne e Pinter.
Il 1981 era stato preparato da un lunga incubazione. Diciamo dal 1968 al 1973, l’anno del grande evento Volterra73, al 1977 con “l’occupazione” della straordinaria Abbazia di San Zeno, incastonata, in quanto alta gioielleria architettonica, in un’oasi di pietre e raffinate costruzioni policrome.
Ricordo che io e altri amici (Marco Giaconi, filosofo normalista, in procinto di partire per Zurigo, Pierantonio Pardi da poco laureatosi con una tesi sull’universo critico di György Lukács e io, che ancora spantalonavo come dottore in lettere, momentaneamente in prestito presso la Facoltà al collegio Ricci) ci prestammo, soprattutto perché giustamente convinti di imparare qualcosa di serio, e di nuovo, a tenere i rapporti con Istituti, Enti, testate giornalistiche, laboratori artistici e critici. Insomma, non solo ci inventammo una competenza storico artistica che, come ben sapeva Trafeli, era inesistente, ma anche come addetti stampa. Non so per quale miracolo (cfr la “stocastica”evocata da Einstein nella lettera di cui sopra), ma con qualche gaffe (celebre quella sui due professori Russo, Luigi e Carlo Ferdinando… per distrazione confusi oltre ogni tolleranza anagrafica), con alcuni sbilanciamenti, riuscimmo a dare un contributo serio fino alla prima del Concerto per lampadina, spettacolare costruzione di luci (i tasti-interruttori di un pianoforte, rivisitati dallo scultore, accendevano lampadine di vari colori sospese in verticale sullo strumento) capaci di evocare nel pubblico percorsi musicali suggeriti alla mente dall’inseguirsi dei colori. Fino al cambio di voltaggio finale.
Dalla gioia di un Sessantotto, libertario e non ideologico, alle innovazioni radicali dei sistemi d’arte, alla Ragione insidiata, alla riscoperta della funzione liberatrice dell’intelligenza vista come Arte come Amore, è compreso tutto l’incanto delle sorprendenti scoperte di Mino Trafeli, inarrestabile nella ricerca di ciò che non può essere mai completamente trovato. Tutto documentato, tutto rimasto, a detrimento della labilità dei materiali, nel racconto dell’arte, nell’anima dei testimoni, tutto indistruttibile come l’intelligenza che si fa spettacolo.