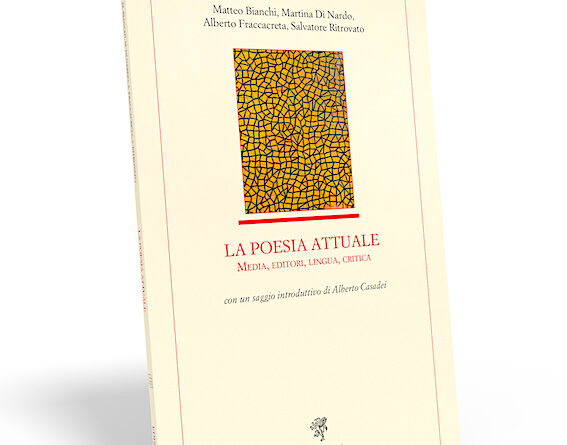M. Bianchi, M. Di Nardo, A. Fraccacreta, S. Ritrovato, La poesia attuale. Media, editori, lingua, critica. Introduzione di A. Casadei, ETS Edizioni 2024, p. 72
Non è facile oggi stabilire che cosa sia poesia, in assenza di sicuri canoni di riferimento e davanti a una produzione che cresce a vista d’occhio: nel 2017 c’erano tre milioni di poeti soltanto in Italia. Ricercatori e critici attenti come Matteo Bianchi, Martina Di Nardo, Alberto Fraccacreta, Salvatore Ritrovato affrontano il problema in La poesia attuale. Media, editori, lingua, critica, ETS edizioni.
Alberto Fraccacreta riconosce che alla poesia è dedicato molto spazio sui social e sul cartaceo, fa un ampio elenco di riviste e giornali, ma purtroppo deve anche riconoscere che legge poesia chi scrive poesia, che la comunità poetica è una comunità chiusa. Vede diffusa una maggiore facilità di versificazione, priva di labor limae, una poesia destrutturata, che spesso è “semplice estrinsecazione in a capo di un pensiero, di una emozione sfuggente, rispondente al bisogno del soggetto e a una necessità di mercato, in un linguaggio che si avvicina, come modalità espressive, a un pezzo di giornale: tutto ciò rischia di mettere in dubbio che la poesia possa sopravvivere ai suoi autori. Tuttavia, scrive Fraccacreta “che il mondo sia abitato da milioni (se non miliardi) di poeti, che essi abbiano la facoltà di apparire costantemente in giornali cartacei e on line, può rappresentare soltanto una risorsa, se “le legioni di poeti […] abbandonate le logiche solipsistiche […] si uniscano finalmente in una solidale ecclesia improntata sul noi, in un’umile coralità dialogica o non siano presto condannate a una irrilevanza politica e culturale”.
Parla di spaesamento evidente, senza una mappa per orientarsi nel mondo della poesia, Matteo Bianchi, di “caos commerciale esasperato dall’avvento del mercato online e dalla mercificazione dei profili social”, per cui è urgente scremare il suddetto marasma per educare alla fruizione e educare a capire “cos’è buona poesia, cosa arbitrio, cosa maniera”, percorso tuttavia complesso anche per un critico. Ricorda i due filoni individuati da Gianfranco Lauretano nell’annuario della poesia italiana contemporanea, L’anello critico 2023: da una parte un nuovo petrarchismo, dall’altra una neo-avanguardia che “persegue una poesia di annotazione, diaristica e prosastica, volutamente sliricizzata e priva di musica”, filone che si fa risalire a Satura di Montale. C’è comunque chi rifiuta la neo-avanguardia, come la “linea metrico espressiva” di Giacomo Trinci, i “sonetti musicali di Alessandro Agostinelli”, lo “scavo versificatorio nella cultura popolare di Alba Donati”. Ricordando una vasta gamma di case editrici di poesia, oltre agli “editori radicali liberi”, Bianchi ammette che i canali social abbassano la qualità della poesia, portando una fruizione frivola e innalzando il sensazionalismo dei (finti) contenuti, ma non può esimersi dall’affermare che “nonostante per i tradizionalisti la carta sia rimasta il rifugio assoluto di ogni poiesi, in quattro lustri il web si è mostrato un terreno di ricerca, e al contempo un deposito, sempre più attento, ambito e corteggiato perfino dall’accademia”.
Martina Di Nardo, nella sua analisi Rifondare la conoscenza. La lingua della poesia, ne ricerca una funzione che freni la moltiplicazione di prodotti che “si sono sfaldati nella inconsistenza del tutto lecito e si sono appiattiti nel frastornante tutto uguale del mondo del pensiero e della lingua globalizzati”, e si sofferma sulla produzione di Maria Grazia Calandrone, Alessandro Agostinelli e Antonio Riccardi.
Della Calandrone, che affida alla poesia il dovere etico di reagire al bombardamento di informazioni cui la globalizzazione ci sottopone, in una funzione etica ed estetica della parola, individua uno dei leit motiv, cioè la compromissione tra corpo e parola: Corpo, affiorante nonnulla / dell’essere, cuspide respirante -vera- arsa di sogno in sogno. Nella sua lirica, afferma Di Nardo, “è solo attraverso l’essere niente del corpo rispetto a tutta la cosa enorme che è una persona, che possono prodursi tracce intellegibili di una vita altrimenti sommersa”. Dalla prosa lirica Giardino della gioia cita la riflessione della Calandrone: “la poesia è anarchica, risponde a leggi solo proprie […] La sua legge interiore è ritmo, musica assoluta. Questo spiega la commozione che proviamo nell’ascoltare letture di poesie in lingue a noi sconosciute. […] perché le nostre molecole consuonano con la lingua stessa della poesia, che è la stessa in ogni lingua: un ultrasuono, un rumore bianco”.
Sulla autonomia e musicalità della parola poetica Martina Di Nardo trova un legane esplicito tra la Calandrone e Alessandro Agostinelli di cui ricorda il prosimetro Le vive stagioni: scopo di Agostinelli è dimostrare “quanto sia necessario per la poesia il suono, il ritmo, la scansione sillabica e la scelta delle lettere in ogni parola, per creare, anche senza alcuna senso, una lingua che risponda a musicalità e emozioni”. La dimensione ritmica è essa stessa elemento semantico, dato che, come ricorda Agostinelli citando Giudici, “la lingua della poesia è […] una lingua diversa […] dove la parola non è soltanto ciò che significa, ma significa ciò che è”. La ricerca dell’io lirico è uno dei temi ricorrenti di Agostinelli, spesso legato alla tematica dell’eterno viaggiare, come ne Il materiale fragile del 2021: “viaggio solo sulla strada del moncayo /verso Lisbona /dentro le mire di una notte atlantica /che inizierà dal cibo e tornerà alle parole / alle memorie del nostalgico / andirivieni dell’altrove / e sento tutto il mio andare”. Sono le parole, la lingua, ad avere “una funzione guida per la capacità squisitamente poetica di palesare all’io le sue stesse memorie”, in una compromissione di vita e scrittura: alla parola, come essere-seme, è affidato l’accesso all’infinito, il saldo tra il qui e l’altrove, il persistere della lingua oltre la consunzione cui tutto il resto è condannato.
Invece la poesia di Antonio Riccardi si caratterizza per la parola liricamente evocativa, “carica di verità, razionale, pragmatica, essenziale e diretta, concisa, senza sprechi”; […] una lingua di fibra robusta” senza aggettivi, con cui lui “indica essenze, sostanze, elementi primi”. In Riccardi torna l’uso dell’iperonimo cosa, semplicemente un inconnu che “apre a infinite congetture nel regno dell’immaginifico”. L’iperonimo terra porta a fonderie industriali, al corpo di fabbriche per la produzione di armi in serie, per cui dovere e sacrificio si impongono alla vita umana spegnendone ogni velleitarismo, ogni fantasia: “in grazia di un luogo conosco /come Dio non ha grammatica / e forgia solo primi nomi: /dovere, sacrificio, verità”. Davanti all’horror vacui dell’esistenza, la lingua, la sintassi, la grammatica della poesia costituiscono solo una possibile verità interpretativa […] in virtù del suo essere costruzione, lavoro, poiein.
Anche Salvatore Ritrovato si chiede come riconoscere la poesia e si dà una possibile risposta: “la si riconosce a seconda di come la interroghiamo e di quello che chiediamo, o meglio in relazione a quello che lo spirito dei tempi ci spinge a chiedere”. Poesia che non ha bisogno di alcun accompagnamento ritmico perché è musica, che non si misura dalla scelta del contenuto, in quanto è libertà: quello che conta è la sua dimensione ontologica, il suo attingere alla sfera interiore di ciascuno di noi. Poesia che può raccontarci quello che succede intorno, ma che deve guardare in alto, interrogarsi sul senso e nonsenso di ciò che accade, perciò il suono della parola del vero poeta deve essere sempre verticale. Per Ritrovato la poesia è un ponte, il poeta “è quello che fa; vichianamente, conosce quello che fa”. […] “Nel dire essere e fare coincidono”. Al di là di ogni premio e riconoscimento, sarà ciò che il poeta scrive a traghettare il suo essere nel tempo e a far sopravvivere la sua poesia.