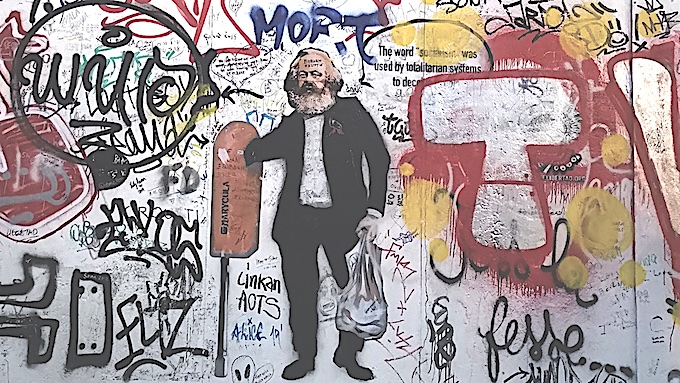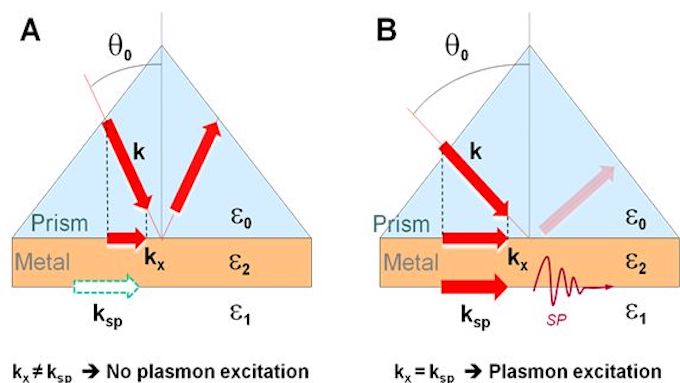I demoni di Marx
Cinquantun’anni prima che Karl Marx e Friedrich Engels scrivessero il loro Manifesto (1848), Johann Wolfagang von Goethe dava alle stampe una poesia: L’ Apprendista stregone. Da quel fatidico 1797, il mito del giovane e inesperto suscitatore di incantesimi i cui demoni non riusciva, poi, a dominare era molto conosciuto in Germania. Nel 1847, Parigi restava il centro della rivoluzione. Gli intellettuali del «Comitato comunista per la corrispondenza da Londra» della capitale francese erano legati a doppio filo col «Comitato di corrispondenza» di Bruxelles. I vagabondi parigini costituivano i seguaci perfetti che Engels stava cercando. Entrambi, intellettuali e vagabondi, non capivano ancora bene che cos’era il comunismo; che cosa la rivoluzione, che cosa dover analizzare, alla fine, criticamente. Marx, immediatamente si poneva in una posizione polemica nei confronti della Lega. La sua era una considerazione scientifica della realtà e, nello stesso tempo, la proposta di una partecipazione consapevole al processo rivoluzionario. Ecco perché, nella prima parte del Manifesto del Partito Comunista, fa il suo ingresso, proprio, uno «spettro». Con tanto di «catene». «Le classi dominanti tremino davanti a una rivoluzione comunista. I proletari non hanno nulla da perdere in essa fuorché le loro catene».
Intanto, i «demoni» evocati dall’apprendista stregone, facevano il loro ingresso. La borghesia, nel corso della propria evoluzione storica, aveva allargato il proprio campo di azione ma aveva anche fatto maturare i germi della propria dissoluzione. Questo fu il punto di partenza di quello che è stato definito «Uno dei più grandi scritti politici di tutti i tempi». In questa storia entra pure un orologiaio: Josef Moll. Costui venne inviato a Bruxelles per convincere Marx a entrare nella Lega dei comunisti (in questo modo si chiamarono i giusti, dall’estate del 1847) e a redigere un manifesto programmatico, insieme a Engels. A testimoniare che, pur nel mezzo del 1848, tutto era ancora chiaro e distinto e cartesianamente misurabile, l’orologiaio stabilì i tempi. I demoni di Marx lo accompagnavano. Lo spettro aveva la forma di un partito politico. Quello comunista.
Il 21 febbraio 1848, il Manifesto venne finalmente pubblicato. A rileggerlo oggi ci si accorge che non ha perso in nulla della sua attualità. Il punto veramente più pregnante appare quando Marx ed Engels fanno riferimento alla «coscienza» di classe. Gli operai, in sostanza, disgregati e smembrati come erano, dovevano acquistare una consapevolezza non più singolare ma plurale. E questo nuovo stadio del loro sviluppo avrebbe dovuto coinvolgere: l’attuale cultura borghese (nella quale comunque erano inseriti) oltre che l’avanguardia politica del movimento operaio stesso, il Partito Comunista. Per fare ciò, anche l’intellighenzia avrebbe dovuto porsi dal punto di vista degli operai. Una volta acquistata questa coscienza, del tutto antitetica a quella della classe antagonista (la borghesia), allora questo rapporto dell’anima con sé stessa e questa relazione immanente all’uomo interiore per la quale egli può non solo conoscersi ma anche giudicarsi, certamente sarebbe stato proprio il Partito Comunista. Vera e propria autocoscienza dell’intero processo storico che aveva fatto sì che la borghesia nello stesso tempo in cui ampliava le proprie forze di produzione, le vedeva scontrarsi con le condizioni stesse della produzione, il Partito Comunista avrebbe raggruppato e unito tutte le energie fino a quel momento libere. I demoni della borghesia non erano riusciti a frenare la contraddizione. La contraddizione, o crisi, si era verificata allorquando tra gli oppressori e gli oppressi si era raggiunto un punto oltre il quale non si poteva andare. I demoni di Marx erano tale contraddizione per sciogliere la quale c’era bisogno che uno spettro si aggirasse «Per l’Europa». Solo i fantasmi conoscono il pandemonio. E se è vero che un demone può essere anche il Genio Maligno di Cartesio, è altresì vero che non tutto il male viene per nuocere.
Il genio Maligno immaginava per noi il nostro mondo; e ci mentiva. I demoni di Marx consentono alla classe operaia, raccolta adesso in partito politico, di ribaltare il verdetto della storia. Lo spettro del comunismo ha agito sui demoni: li ha fatti diventare consapevoli. In definitiva, «Il comunismo non toglie a nessuno la facoltà di appropriarsi dei prodotti sociali, ma toglie solo la facoltà di giovarsi di tale appropriazione per assoggettare il lavoro altrui». La parola definitiva è sempre quella: sfruttamento. Man mano che la società si proletarizza, la borghesia perde terreno. Man mano che la borghesia avanza, i proletari crescono di numero. E di rabbia. Il 7 febbraio è dunque una data emblematica. Probabilmente le profezie di Marx ed Engels non si sono mai realizzate, ancora, pienamente. Quello di veramente interessante di questo «Manifesto» è che tutto lo sviluppo storico viene dipinto come oggettivo, necessario e inevitabile. La contraddizione hegeliana viene, adesso, portata su un altro livello. La risolverà uno spettro, con la sua violenza rivoluzionaria e non un atto sintetico, che resta pur sempre qualcosa che appartiene al pensiero. Il Manifesto del Partito Comunista, se riletto oggi ci insegna quello che, con altri termini, Hans-Georg Gadamer ha affermato in Verità e metodo. «Se una cosa non la conosci, non la puoi desiderare». Se non si acquista coscienza di qualcosa, non si può operare per qualsivoglia cambiamento. Oggi lo schema dicotomico utilizzato dai due redattori del Manifesto appare da rivedere. La lotta c’è sempre. Gli oppressori e gli oppressi ci sono sempre. Le classi sociali, però, hanno mutato indirizzo. Non più borghesi e proletari; la nuova diseguaglianza si chiama digital divide. E cioè quella tra chi è connesso (on line) e chi non è connesso (off line) alle grandi autostrade informatiche che solcano il Pianeta.
Le crisi del capitalismo, ormai esteso a globalizzazione, si alternano l’una con l’altra proprio come Marx ed Engels avevano indicato. E la contraddizione? Per sciogliere la contraddizione attuale occorre una presa di coscienza. Ma per prendere coscienza, e desiderare, qualcosa occorre, oggi, un’operazione quasi inumana di surfing tra fake news, social media, influencer. Tiktoker, gusti della casalinga di Voghera, luoghi comuni e una Generazione Z che «Legge e non capisce quello che legge». Se nel 1848 questo compito era da demandare a un partito politico, la situazione adesso pare molto più incerta. Che ne è della politica? Stretta tra un neoliberismo imperante e una demagogia da salotto televisivo, la politica è diventata un funzionario dell’economia. Un suo amministratore. Un notaio. Qualcosa che ratifica e che non propone. A chi dunque il compito di sciogliere la contraddizione attuale? L’aporia tra la società del 99% e quella del 1% che sta bene. Il paralogismo di un Pianeta sfruttato fino all’inverosimile e che reagisce col cambiamento climatico. Nuovi demoni è necessario che si addensino all’orizzonte. Qualche nuovo apprendista stregone deve sbagliare la sua magia. Troppi spettri oggi si aggirano per l’Europa, Ucraina in testa. Troppi incantesimi ci hanno incantato. I demoni di Marx hanno comunque avuto un senso. Hanno avuto il senso di scuotere un intera generazione e forse un intero secolo. Certe volte, è vero, il rimedio è peggiore del male. Ma il male deve essere esorcizzato, in qualche modo.