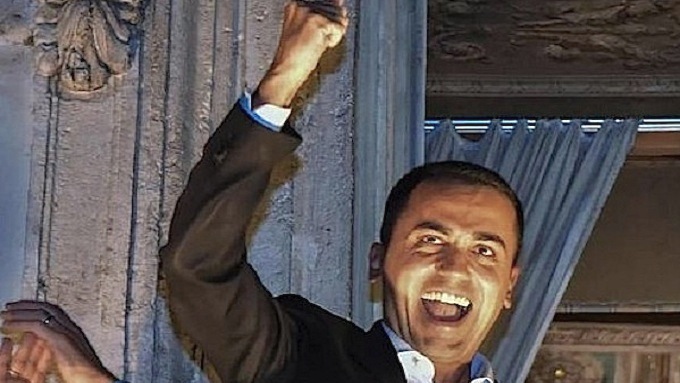Altissima povertà
Nel 2023 (ultimo anno per il quale si hanno dati ufficiali) versavano in condizione di «povertà assoluta» circa 5,7 milioni di italiani. Con il lemma «povertà assoluta» si intende quella condizione nella quale non si riesce a far fronte alle spese minime per il proprio sostentamento: acqua, cibo, vestiario e abitazione. Secondo un recente sondaggio della Demos circa il 49% degli italiani, oggi, ritengono di non appartenere più alla classe-media. E conseguentemente costoro avvertono la propria situazione come proletarizzata. I giovani non riescono a immaginare un futuro possibile; questa è la prima generazione della storia di giovani i quali hanno meno opportunità dei loro padri. La crescente proletarizzazione degli italiani (o meglio: della percezione che gli italiani hanno di sé stessi) si innerva soprattutto nei disoccupati, in chi svolge lavori casalinghi e, naturalmente, negli operai. Il filosofo Giorgio Agamben, nel 2011, ha pubblicato un libro dal titolo Altissima povertà, nel quale, provocatoriamente, indicava nello stile di vita dei francescani un’alternativa possibile al capitalismo e alla globalizzazione (a trazione finanziaria e delle agenzie di rating).
In questione, adesso, non sembra essere soltanto una condizione socio-economica, piuttosto un sentimento. Il pessimismo che sembra avvolgere la percezione che di sé stessi hanno gli italiani ha certamente radici lontane. Lo scrittore Francesco Piccolo, vincitore del Premio Strega nel 2014 con Il desiderio di essere come tutti, riflettendo sul ventennio di Berlusconi, dichiarava candidamente: «In tutto quel periodo io sono stato infelice».
Pessimismo e infelicità derivano certamente, per quei 5,7 milioni di italiani di cui si diceva, dalla propria condizione economica. Ma per il 49% di italiani che facevano parte della classe media e che adesso si sentono proletari il discorso è diverso. Evidentemente Antonio Gramsci è ancora attuale. Nei Quaderni, Gramsci parlava di «pessimismo dell’intelligenza e ottimismo della volontà». Quello che per la metà degli italiani sembra paralizzato oggi è proprio l’ottimismo della volontà. Fare, fare, fare, ma per fare cosa? Facendo non muta la propria condizione.
E poi: non c’è niente da fare. Le regole che sovraintendono alle nostre società ci trascendono. La globalizzazione è dappertutto e in nessun posto. La “casta” è estranea ai desiderata delle persone. Il rapporto “organico” tra cultura e politica si è spezzato; il cosiddetto partito non fa più riferimento alle masse.
In passato i partiti popolari si rivolgevano a uno “zoccolo duro” di elettori (categorie economiche e professionali) con il quale stabilivano un rapporto di coerenza tra la proposta politica e i problemi e gli interessi di quelle categorie. Oggi vige invece la post-verità. Come diceva il criminale nazista Goebbels: «Ripeti una bugia venti volte ed essa diventa una verità». Ecco dipanarsi tutto un viluppo di terrapiattisti, comunità di scettici, increduli sulla vaccinazione anti-Covid, gente che non si va più a curare (anche in presenza di malattie gravi) perché non crede nel sistema sanitario nazionale…
In questo marasma, l’individuo evidentemente pessimista ha perso il fuoco, il centro, il fondamento. L’ultimo efferato omicidio, compiuto da madre e compagna di un cittadino italiano, dimostra quanto di arbitrario, effimero e gratuito sia entrato nelle nostre vite. La giurisprudenza ha un termine: «futili motivi».
La perdita dell’ottimismo della volontà produce i futili motivi. I futili motivi per i quali si vive; non per i quali si uccide. L’idea di Agamben della «povertà assoluta» come rimedio all’accaparramento per niente relativo del capitalismo non è malaccio. Mi ricorda tanto una ragazza di Cittanova, in provincia di Reggio Calabria, che dopo una mia conferenza mi disse: «Professore, lei ha parlato di MacDonald’s, Ikea, della globalizzazione… Sa quale è la mia soluzione? Io da MacDonald’s non entro».
In fondo anche questa è (come diceva Ulrich Beck) una «soluzione biografica a una contraddizione sistemica».
Ma il pessimismo? L’azzeramento della volontà? Io posso non entrare affatto nel MacDonald’s ma continuo lo stesso a vedere nero davanti a me. E penso che la mia classe sociale oggi si sia proletarizzata. Mi vedo futile, povero e infelice. La povertà può essere di tanti tipi. Quella economica, che sta comunque aumentando, è solo una fra le tante. Oggi sappiamo che per grandi numeri di connazionali esiste anche un’altra povertà: siamo poveri di speranza.