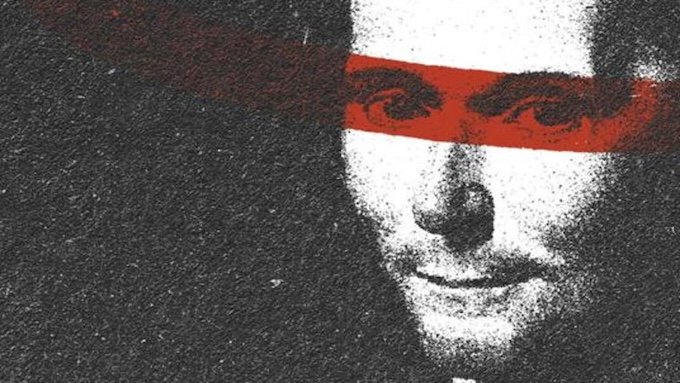Roberto Esposito (a cura di F. Del Lucchese, E. Zaru), Machiavelli, DeriveApprodi, 2025
«Il quale [Licurgo] ordinò in modo le sue leggi in Sparta, che, dando le parti sue ai Re, agli Ottimati e al Popolo, fece uno stato che durò più che ottocento anni, con somma laude sua e quiete di quella città», così, nei Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, scrive Niccolò Machiavelli, citato da Roberto Esposito. Filippo Del Lucchese ed Elia Zaru hanno messo assieme una sorta di antologia (Machiavelli, In appendice un’intervista inedita dell’autore) di tutti gli scritti che, nel corso della sua carriera, Esposito ha dedicato al Segretario fiorentino. «Con somma laude sua», Esposito traccia una sorta di cartografia del pensiero politico di Machiavelli centrando la propria attenzione, appunto, sui temi dell’ordine (come quello dato da Licurgo a Sparta) e del conflitto. «La politica occupa l’intero quadro della realtà»; «La politica occupa l’intero orizzonte del reale»; «Non è il potere a scorrere nella storia, ma la storia a scorrere nell’alveo del potere». Dunque: la politica è auto-fondata; non esiste un pre-politico come non esiste un post-politico. In una situazione di questo tipo, ordine e conflitto stanno in una relazione biunivoca: uno implica l’altro. È una «Concezione radicalmente conflittuale, antagonistica, competitiva, della politica». Il pensiero di Machiavelli: «Si lascia pervadere dal reale fino ad assumerlo come tale, nella sua qualità costitutivamente antinomica, senza temere di entrare in contraddizione con esso». Infine: «Il ruolo della politica è quello di governare la tensione conflittuale naturalmente scaturita dai diversi interessi in gioco», ovvero: «Fare politica vuol dire contenere tale tensione all’interno di “termini civili”, ma la fine della tensione segnerebbe la fine stessa della politica».
L’ontologia politica di Niccolò Machiavelli è esattamente quella dell’eccitabilità e dello sforzo (connesso anche al rischio). Esiste un «equilibrio instabile» che va governato. Il conflitto (tra le parti sociali; quello che marxianamente siamo abituati a chiamare «lotta di classe») reclama un ordine che lo contenga; per parte sua: ogni ordine possibile si regge su un conflitto. Fino a quando la politica riesce a stabilizzare, in qualche modo, questa tensione le cose vanno bene. Quando «forme private ed economicistiche» emergono all’interno della dialettica ordine-conflitto, portando alla inevitabile catastrofe (Esposito dice: alla «crisi»), allora, occorre operare una torsione. Tornare al passato. Tornare all’origine. Tornare alla politica del passato. Ma non in senso conservativo. Utilizzare questo passato (nella fattispecie, Machiavelli ha di mira Roma) nel senso dell’innovazione. Il nuovo, che ne deve scaturire, sarà quello che riuscirà a incanalare, moderare e incapsulare il conflitto rendendolo ancora una volta produttivo di nuove sintesi; ordine e conflitto potranno continuare a fare la totalità della politica. Questa torsione ricorda l’operato, in elettronica, di quel circuito integrato chiamato «Integrato 7805». Si tratta di un regolatore di tensione molto famoso. Esso converte una sorgente di corrente continua da una tensione a un altra mantenendo costante la tensione di uscita indipendentemente dalla tensione di ingresso. Per Machiavelli tale è lo «stato misto». Dunque, per uscire dalla crisi è necessario un circuito integrato. Alla crisi si risponde con più potere, con più politica, con più responsabilità.
È il Principe questo «Integrato 7805»! Il Principe interviene su una sporgenza. «Qualcosa di eccessivo, di sproporzionato, di indefinibile, accadeva: entrava in crisi lo stesso gioco di risoluzione (e sviluppo differenziale) della crisi»; cioè: «La crisi spinge il politico fuori dallo Stato, se lo Stato non ha la forza di gestire il politico», «Perché possa darsi qualcosa come la politica, occorre uno scarto,una deviazione dalla norma, che imprima una scossa alla realtà, impedendole di scivolare nella corruzione cui è (…) naturalmente orientata». Attorno a questa sporgenza, che prima di tutto vuol dire impossibilità di governare la dialettica ordine-conflitto e quindi impossibilità di qualsivoglia politica (la quale finisce per inaridirsi, per ripiegarsi su se stessa, per diventare qualcosa di altro rispetto alla sua stessa natura), il Principe, operando come un «Integrato 7805», riporta nell’alveo politico gli «interessi privati o economici». Di più: «L’immagine del Centauro e la definizione del principe a metà tra la volpe e il leone restituiscono in maniera plastica l’jnsolubilità di questo viluppo». Ordine e conflitto si devono perpetuare anche durante e dopo la crisi. Il realismo di Machiavelli non sono è conseguente; è assoluto. «L’ordine, in Machiavelli, è di per sé conflittuale».
Occorre risolvere la crisi perpetuando, anche, lo stesso conflitto che l’ha fatta sorgere. Il circuito integrato è tale perché distribuisce la tensione. Ma, come opera questo «Integrato 7805»? «Stringendo in uno stesso nodo i poli solo apparentemente alternativi, di ordine e conflitto». Se ne ha allora un ordine conflittuale o (se si preferisce) un conflitto ordinato frutto di una regolazione, di una stabilizzazione e della posa in esecuzione di un «equilibrio instabile» contenuto, controllato e calibrato. Il nuovo scaturisce dall’antico. L’antico offre un punto di vista. Tale punto di vista è utile rispetto alla crisi perché nell’antichità era servito per risolvere situazioni simili. La società è solcata da conflitti continui. E da momenti di pausa nei quali un «equilibrio instabile» garantisce governo e sovranità.
Ma Machiavelli non è un pensatore sovranista; egli non identifica la politica con lo Stato. C’è sempre una sporgenza, una convessità e una gobba. La sua soluzione alla crisi è del tutto politica. Non è securitaria come quella proposta dai pensatori e dai politici sovranisti. E per realizzare questo «più politica» occorre prendere in mano la contraddizione (l’«ordine conflittuale») e farne qualcosa. In sostanza: non avere paura dell’abisso; immergersi nella crisi. Realista più che realista, Machiavelli ci consegna un pensiero per il quale la politica (se guardiamo a oggi, divenuta solo una specie di notaio che attesta le decisioni del neoliberismo economico) può dire ancora la sua.