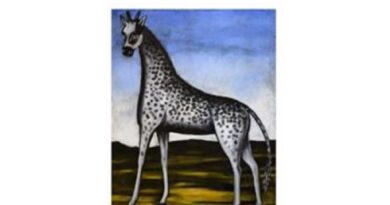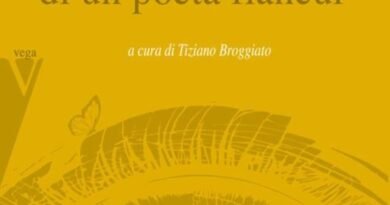Marisa Cecchetti, Il faro di una lucciola, Giovane Holden Edizioni 2025
La produzione poetica di Marisa Cecchetti si delinea nel panorama letterario contemporaneo con un tratto stilistico inconfondibile, fatto di lirismo sommesso e di una profonda, quasi tattile, adesione al quotidiano. La poetessa toscana, autrice prolifica che spazia tra prosa e versi, ha saputo costruire nel tempo una voce limpida e misurata, priva di enfasi retorica ma non per questo meno incisiva.
Il suo itinerario lirico, come testimoniato da raccolte precedenti quali Il vuoto e le forme (2000), È filo di seta (2003) o l’intensa Come di solo andata (2013), si concentra sulla trasfigurazione lirica di situazioni, circostanze e “piccole storie” del vissuto comune. È una poesia di sottrazione e di dettaglio significativo, dove l’occhio dell’autrice è costantemente teso a cogliere la “pepita dorata” insita anche nelle vite più semplici. La memoria e il ricordo sono elementi cardine, non come fuga nostalgica, ma come radice viva che alimenta la comprensione del presente, in un continuo dialogo tra il «già stato» e l’«esserci pienamente nella vita, qui ed ora». Ne risulta una scrittura pulita, controllata e disciplinata, che risuona di armonie e, talvolta, di disarmonie, sempre però permeate da uno stupore grato e una compassione autentica verso l’umano e il paesaggio, come emerge con forza nel poemetto Questo ondulare della terra (2023) in cui l’intimità del ricordo si confronta con il dramma delle crisi ambientali e sociali.
In questa parabola, la breve silloge Se mi porti con te (Giovane Holden Edizioni, 2020) si colloca come un tasselloemotivo cruciale nel percorso di Marisa Cecchetti, assumendo la valenza di una testimonianza lirica nel vivo della pandemia da Covid-19; attraverso i suoi ventisette testi, la poetessa registra il «pietrificarsi della vita» sotto il gelo del Covid, traducendo in versi l’esperienza di un tempo sospeso sine die.
Mantenendo l’abituale tono sommesso e modesto, e la preferenza per un lessico controllato, Cecchetti introduce qui sfumature che evocano un’apprensione inedita, una nuova paura. La sua poetica, solitamente orientata verso la luminosità del dettaglio memoriale, si trova a confrontarsi con il «morbo subdolo e invasivo» e lo sgomento di un’epoca che si riteneva immune a tali sciagure storiche. L’«arredo dei suoi versi», sebbene rimanga disadorno, si riempie di un lessico inusuale per l’artigiana della parola ordinata: si avverte il senso di un profondo disorientamento e di una clausura forzata che paralizza l’esistenza.
Ciò che colpisce è come la poetessa elabori la nuova normalità non attraverso un’invettiva o un’esplicita denuncia del dolore, ma fissando l’attenzione sul silenzio che ha invaso lo spazio sonoro e sul vuoto che ha ridefinito le relazioni. I versi diventano l’unica liturgia rimasta, capaci di dare forma all’assenza, tema cardine che Cecchetti aveva già esplorato, ma che qui si dilata fino a farsi esperienza collettiva di una débâcle spirituale e mentale.
La richiesta implicita nel titolo, Se mi porti con te, non è un’invocazione di salvezza in senso fisico, ma sembra piuttosto un appello alla memoria salvifica o alla condivisione del trauma. La poesia si fa ponte fragile ma necessario tra l’io segregato e un mondo esterno percepito come minaccia o, peggio, come irrimediabilmente mutato. Il timore non è solo quello del contagio, ma della perdita di contatto umano, della disgregazione dei riti sociali e affettivi. La silloge è, in ultima analisi, un diario intimo in cui l’inquietudine è filtrata da una sensibilità che cerca comunque il dettaglio vitale, la scintilla di resistenza, confermando la Cecchetti come una raffinata evocatrice capace di far emergere la bellezza e il dolore nascosti nelle pieghe del presente.
L’ultima silloge poetica di Marisa Cecchetti, Il faro di una lucciola (Giovane Holden Edizioni, 2025), non è perciò soltanto l’ennesima prova di una penna avvezza alla misura e alla sobrietà, ma si pone come il punto di approdo significativo e, per certi versi, risolutivo, nel percorso lirico della poetessa toscana. In un panorama letterario spesso incline all’eccesso o all’autoreferenzialità, Cecchetti ribadisce la sua adesione a una classica compostezza: il suo è un dettato che predilige la musicalità intrinseca e una struttura del verso che funge da cassa di risonanza per emozioni sottili anziché per enfasi retoriche.
Questa raccolta finale non disperde i temi centrali della sua opera – la Natura vissuta in una dimensione casalinga e mediterranea, la Memoria come radice viva e la riflessione sul quotidiano come luogo di epifanie –, ma rielabora tutto attraverso la lente di una rinnovata, seppure fragile, speranza. Per questo, per comprendere appieno la luce de Il faro di una lucciola, era essenziale dilungarsi e tracciare una linea di continuità e di sviluppo con Se mi porti con te (2020): una silloge, si è visto, permeata da una tensione inedita, che registrava con la consueta misura il trauma e l’inquietudine derivanti dalla reclusione pandemica. Il silenzio era lì un fattore imposto, veicolo di una nuova angoscia, e la memoriafungeva da àncora in un tempo percepito come sospeso e alieno. La richiesta implicita nel titolo, Se mi porti con te, suonava come un appello alla condivisione del trauma e alla ricerca di una salvezza non fisica ma spirituale.
Ora in Il faro di una lucciola assistiamo a un cruciale spostamento emotivo e prospettico. La poetessa non dimentica la lezione di quel tempo sospeso, ma elabora l’assenza e la paura trasformando il silenzio da vuoto paralizzante a spazio di attesa creativa e scavo interiore. Qui il silenzio è luogo in cui le emozioni non vengono sminuite, bensì accudite e dilatate.
Il titolo, con l’immaginario della lucciola ripristina il concetto di una luce effimera ma necessaria in opposizione all’oscurità attraversata, una luce che l’autrice intende come quel «fioco lume» che ogni essere irradia e che si tratta solo di saper cercare. È il definitivo superamento del senso di disgregazione: se in Se mi porti con te si avvertiva la minaccia di una débâcle mentale, in questa raccolta si ritrova un’armonia fragile tra perdita e rinascita.
La Natura acquista un ruolo quasi mistico: non è più muta testimone della reclusione, ma diventa specchio dell’anima e catalizzatore di un’epifania non sempre rassicurante («chiamo a raccolta le emozioni / che ho conosciuto già / non accorrono svelte / e non sussulta il cuore / come sa… / Forse è per l’aria greve / che ci grava addosso / carica di domande e di paura / che uccide la bellezza»). I paesaggi toscani, realistici e lirici insieme («le Apuana di marmo dentellate»), non sono semplici scenari esterni, ma dimensioni interiori in cui la pioggia, il vento tra i filari della vigna e le colline racchiudono il peso dei ricordi e la promessa di un ritorno. La Cecchetti realizza un’operazione di trasfigurazione costante: gli elementi botanici e naturali – dal gelsomino all’ulivo, dal grano («Tra i campi grandi / qui dove il grano è biondo / sussulta l’occhio a una ferita / di papaveri rossi…») alle pioppete («Ora che le pioppete dalle foglie fragili / mi accompagnano in via / – ne percepisco la presenza / senza alzare lo sguardo / ombra lunga e leggera / mossa dalla brezza – / colgo una luce insolita / che attraversa il vuoto…») – vengono definiti con concretezza e attenzione quasi scientifica, ma assumono immediatamente significati simbolici mai scontati, fungendo da rintocchi emotivi che portano in superficie riflessioni sulla precarietà e sul valore della bellezza effimera.
La memoria non è più soltanto un’ancora di salvezza, ma un dialogo attivo che conferisce senso e coesione al presente. Il passato affiora senza i crismi del rimpianto sterile, ma come una riscoperta del legame profondo con la propria storia («il tempo ruba agli occhi / la concretezza del passato»). Questa ricerca di senso si manifesta attraverso il suo tipico lirismo del dettaglio: sono i piccoli gesti e i modesti fatti quotidiani che, illuminati dalla sensibilità dell’Autrice, si trasformano in universali motivi di attenzione e di una simpatia piena d’amore per l’esistenza («sola nel prato / ho ascoltato fringuelli / chiacchierare fitto / non li ho cercati tra le fronde / sembravano / il vecchio trillo della radio / di sicuro / erano notizie belle / di sicuro / erano allegri»).
In definitiva, Marisa Cecchetti, attraverso Il faro di una lucciola, offre una poesia di resistenza e resilienza. La sua scrittura, dolce e avvolgente come una brezza estiva, ma all’occorrenza tagliente come il vento invernale, invita a un cammino lento tra ricordi e stagioni, illuminando l’animo con la luce persistente e delicata di una poetica che, avendo attraversato la notte della paura, ha ritrovato la scintilla della meraviglia nel dettaglio più minuto. È la dimostrazione che la misura e la sobrietà stilistica possono veicolare la più intensa delle profondità emotive.
Hanno piegato il capo i girasoli
pesante
che guardavano fieri avanti a sé
ora chinati a terra
nel crepuscolo chiaro
in file lunghe
mille più mille e mille
sono come un esercito
che si arrende
che si ritira
quasi con vergogna
le corolle larghe
scudi
di legioni in fuga.