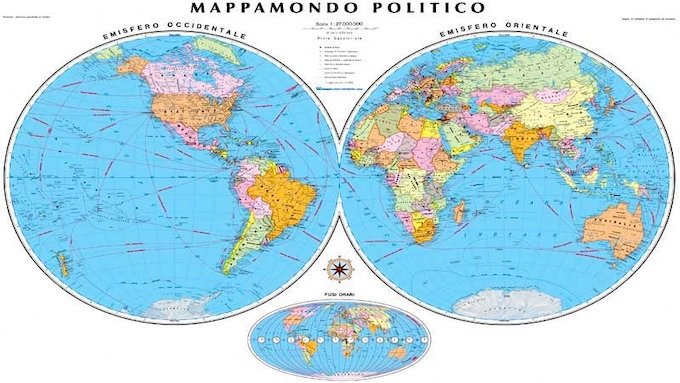Occidente senza Occidente
La Guerra Fredda c’è stata e l’ha vinta l’Occidente. Al posto di un unico governo mondiale, o meglio di una qualche governance transnazionale, si è insediato, oggi, un meccanismo astratto regolato dai mercati con pochissima politica e con sistemi di potere in equilibrio tra specifici e regionali assets in cui si intersecano localismi e militarismi. Una forma evanescente che, ricorda il contrario di quello «spettro» che «si aggira per l’Europa» di Karl Marx e Friderich Engels. Il capitalismo nella sua variante neoliberista, in quanto composto da un’unione algebrica di tecnica, èlite e leadership gestionale-produttiva, ha prodotto, in Occidente, non il «comunismo» ma una «macchina morbida» che ha ridotto la politica ad attestatore-certificatore-testimone della globalizzazione. Dopo la Guerra Fredda, il mondo si è riscaldato di nuovo; e a farlo bruciare è stata non soltanto il germe dei conflitti amico/nemico, ma la strisciante, incandescente, defibrillante ricerca del profitto.
Gli altri due punti di passaggio storici, dopo l’episodio delle Twin Towers, sono stati, ovviamente il 24 febbraio 2022 (invasione russa dell’Ucraina) e le sei di mattina di un giorno di autunno (7 ottobre 2023) nel quale Hamas ha attaccato Israele. Il «surriscaldamento globale» o la «mobilitazione totale» di Ernst Junger ha preso parzialmente il posto – attraverso i due anni di interregno del Sars-CoV-2 – del potere dei soldi, il quale, però, non è mai finito.
Lo stato attuale è stato egregiamente descritto come una crisi nella quale il caos ha preso il posto dell’ordine. L’equilibrio generato dai mercati, però, non era qualcosa che era caduta dal cielo. Era, e sostanzialmente è ancora, valido solo perché tutto sembrava funzionare abbastanza bene. La società mondiale è stata definita, volta per volta, claustrofobica, soporifera, sonnambolica, anomica, galleggiante, sedata, sospesa, priva di orientamento e, anche, da un testo mai scritto da un umano ma da una macchina «ipnocratica».
In un contesto del tutto diverso (la prima parte del libro fu pubblicata nel 1918), Oswald Spengler ne Il tramonto dell’Occidente ha scritto: «Ma per noi, posti da un destino in questa civiltà e in questo punto del suo divenire in cui il denaro celebra i suoi ultimi trionfi e in cui il suo erede, il cesarismo, ormai avanza silenziosamente e irresistibilmente, è strettamente definita la direzione di quel che possiamo volere e che possiamo volere, e che valga la pena vivere». È stata proprio la mancanza di «direzione» (cioè di orientamento e di gestione) che ha condotto l’Occidente a suprematismi e sovranismi, a populismi e nazionalismi, a corporativismi e identitarismi. L’Occidente si è caratterizzato, da sempre, per il suo pluralismo. Per gli ideali democratici di eguaglianza e libertà. Per il suffragio universale e la rappresentanza. Per i concetti di emancipazione femminile, diritti dell’uomo, laicità dello Stato, istruzione pubblica universale, valori democratici e giustizia. Per la mancanza di autoritarismo insita negli ideali progressisti che, anche nei momenti di maggiore buio, lo hanno accompagnato. Ma, se è vero che il potere, inteso come dominio, ha continuato a esserci, è del resto sacrosanto che la mèta ultima, il fine, lo scopo, il telos si è perduto.
Il pianeta ha attraversato una fase – che noi giudichiamo transitoria: stiamo vivendo in un “tra” – e nella quale la tecnica, il cui ultimo ritrovato è l’intelligenza artificiale, ha ristretto la geografia e amplificato le differenze. La connessione generalizzata degli esseri umani, realizzata nello spazio astratto di un meccanismo impersonale, ha realizzato un mondo privo di spazio ma ancora ancorato ai “tempi” dell’umano. La solita vita quotidiana, infatti, è rimasta la stessa. Ciò ha generato un cortocircuito, simile a quello teorizzato dalla relatività generale di Albert Einstein, nel quale la forza di gravità ha incurvato lo spazio e ha dilatato i tempi. La gravità del fantasmatico meccanismo tecnico-economico, infatti, ha prodotto la curvatura della politica verso zone d’ombra (nelle quali si deve fare i conti con il bilanciamento fra l’ipertecnologia inevitabile e le tendenze reazionarie più retrive, proprie di questa politica piegata).
E ha prodotto pure ampi margini di tempo libero nella società che sempre più si polarizzata fra nuovi ricchi e una massa morfologicamente amorfa e priva di tensioni ideali o di un’identità sociale, che restava ai margini. In questo senso, il panorama occidentale attuale appare percorso da un ridimensionamento senza precedenti della politica, da un astrazione disincarnata che possiede il potere e, infine, da una mancanza di «direzione» verso cui andare che non ha eguali nella storia.
La massa critica, in fisica, si realizza quando un fenomeno quantitativo diventa qualitativo. Del resto, molti illustri analisti hanno parlato di una «singolarità» oltre la quale la tecnica avrà preso definitivamente il “comando”. Per questo ci stiamo trovando in un “tra”. Tra il vegetare giorno per giorno senza un’alternativa e l’attesa – o meglio la paura – di qualcosa di spietato che ci starà per accadere.
In questo “tra”, come avrebbe amato dire Soren Kierkegaard, si vive come un semplice “forse”. Ma questo “forse” è governato da un meccanismo che appartiene all’approssimazione. L’Occidente, invece, aveva i suoi punti fermi. Quello che si è verificato è che la statistica ha preso il posto della certezza, la meccanica quantistica ha preso il posto della verità. Certo, si può ancora governare la probabilità; con la legge dei grandi numeri, ad esempio. Il punto è che l’Occidente deve farlo senza possedere più la giustificazione dei suoi fondamenti che gli restituivano la propria legittimità. Ci vorrebbe un “pensiero forte”, insomma. La politica dovrebbe ripristinare la realtà.