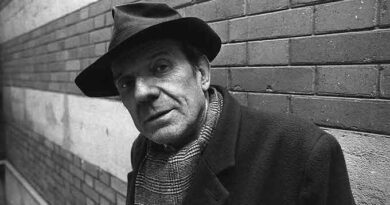«Nel 1925, quando nella Postfazione alla prima edizione del Processo pubblicò le due lettere che sono considerate il testamento di Kafka, Brod spiegò che questi sapeva bene che i suoi desideri non sarebbero stati esauditi» scrive Milan Kundera nel suo libro I testamenti traditi. In quello stesso 1925, viene rivelata l’esistenza stessa della lettera-testamento di Lenin da parte di «un comunista americano che per tale rivelazione fu espulso dal Komintern». Siamo, dunque, di fronte a due Testamenti traditi? Se Franz Kafka era pienamente consapevole del futuro tradimento, Lenin poteva aspettarselo? Luciano Canfora, in questo suo filologicamente impeccabile e brillante Il testamento di Lenin. Storia segreta di una lettera non spedita (FuoriScena, Milano, 2025), indaga il rapporto – tanto caro a Michel Foucault – tra il potere e la parola. In questo caso: la parola scritta da Lenin. Il potere si serve della parola per persuadere; esattamente come gli antichi sofisti greci facevano, per soldi. La parola scritta, e le sue interpretazioni, possono mutare i rapporti di potere? A distanza di cinque mesi muoiono, prima Vladimir Il’ič Ul’janov,noto con lo pseudonimo di Lenin (21 gennaio 1924), poi Franz Kafka (3 giugno 1924). Questi due uomini sono accomunati da delle lettere – due per Kafka e una per Lenin – che sono state considerate i loro «testamenti». Lo scrittore praghese raccomandava di «distruggere la sua opera», il rivoluzionario russo forniva indicazioni per la sua successione. Se è vero che il testamento di Kafka è stato naturalmente «tradito», probabilmente quello di Lenin è stato «disatteso».
I testamenti traditi, secondo Luciano Canfora, appartengono, però, a un altra categoria. «Raramente un documento ha avuto una storia testuale così inquinata e falsificatrice». Lenin, sul letto di morte, scrive alcune cose. Fa riferimento alla sua successione. Individua sei «compagni» che possono, ragionevolmente, prendere il suo posto. Di ognuno di essi porta in luce i «difetti». In questo senso quello di Lenin più che un testamento politico, è un testamento «psicologico». Inoltre, egli lascia aperto il problema della sua «eredità» politica. Di Stalin dice che è rozzo, manca di cautela, prudenza ed è testardo. Di Trockij che è troppo sicuro di sé, baldanzoso e che si è dedicato troppo a faccende amministrative. Che senso ha tutto questo? Canfora è abile. Mette a confronto documenti, articoli di giornale, testimonianze dirette, prese di posizioni ufficiali del «partito» e dei vari Congressi. La relazione potere-parola si rifrange in una rete di ipotesi, considerazioni sorte alla luce del buon senso, approssimazioni probabilistiche dovute ad analisi di testi incrociati. Il potere ha detto la sua parola; la sua parola è ambigua, polivoca e polisemica. Quasi sicuramente Stalin ha operato un «intervento testuale»; ha alterato, manipolato e interpolato. «Alla base di tutto questo ci sono la inconcludenza e la contraddittorietà (e impulsività, per quanto attiene al Poscritto) del “Testamento di Lenin”». Sappiamo come è finita la storia: Trockij «espulso dal partito» ed esiliato e Stalin al «potere». Perché Lenin ha scritto di caratteristiche personali, note caratteriali, dei due antagonisti e non di peculiarità «politiche»? Lenin ha lasciato, di proposito, il proprio «testamento» aperto. Non ha indicato una soluzione. Sembra quasi che l’eroe della Rivoluzione d’ottobre avesse scelto di parlare più con sé stesso che con il Comitato Centrale del suo partito. Che volesse chiarirsi le idee. Al di là delle falsificazioni – che, pure, ci sono state -, Luciano Canfora sembra indicarci una strada precisa. Si punta sulle caratteristiche personali quando la rotta è, oramai, tracciata. L’URSS deve proseguire lungo la via indicata da Lenin; non occorre nessun cambiamento di tipo politico. Ecco perché le personalità dei vari candidati alla «successione» acquistano peso. In questo senso, sembra, la scelta più indicata sarebbe stata quella che riguardava lo stesso Trockij. Che era dotato di «eminenti capacità». «Il compagno Stalin, divenuto segretario generale, ha assommato nelle sue mani un potere immenso, e io non sono convinto che egli saprà sempre usare di tale potere con sufficiente cautela». La relazione potere-parola, quando è declinata sul «piano personale», si innesta nel solco delle «parole dell’uomo di potere» modulate intorno al suo proprio «temperamento». Più che crisi economica, crisi umorale!
I testamenti traditi di Kafka e Lenin lo sono stati perché non li si riusciti a capire fino in fondo. Luciano Canfora sa che «è illusorio immaginare di poter ricostruire in toto un testo “autentico». Nell’ Aggiunta (datata 4 gennaio 1923) alla Lettera la Congresso (del 22 dicembre 1922), Lenin aggiunge: «Perciò io propongo ai compagni di pensare alla maniera di togliere Stalin da questo incarico e di designare a questo posto un altro uomo che, a parte tutti gli altri aspetti, si distingua dal compagno Stalin solo per questa migliore qualità, di essere cioè più tollerante, più leale, più cortese e più riguardoso verso i compagni, meno capriccioso». Ma la lettera-testamento non fu fatta giungere al Congresso del marzo 1923. Ecco come interpreta Luciano Canfora questo drammatico episodio. «Lenin (…) si sarebbe dunque tirato indietro rispetto alla drastica iniziativa affidata al Poscritto del 4 gennaio. Ha preferito non gettare allo sbando il partito privandolo del segretario senza proporre alternative. Ha però voluto che si sapesse, poi, che comunque ci aveva pensato». Dunque? Di fronte alla contingenza e alla Realpolitick va bene anche uno come Stalin. Ma Lenin, nel suo «testamento», chiude il cerchio affermando che in valore assoluto Stalin non va bene. Il potere si serve della parola per legittimare e ammonire.
I testamenti traditi sono egualmente «traditi». Ma quello di Lenin lo è con un senso di sospensione, di dubbio, di non detto in più. In fondo questa è la differenza tra essere e dover essere, che, come si sa, non coincidono mai.